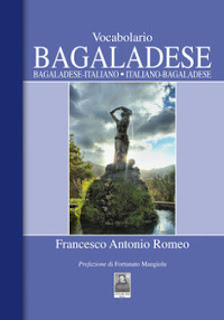di Luciano Luciani
Già all'indomani del massimo rigoglio della storiografia positivista non furono pochi gli studiosi che percepirono tutta l'angustia di una ricerca storica solo ristretta a fatti localizzati e datati: battaglie, trattati, mutamenti di case regnanti, politici che salgono o scendono nel favore popolare, nascita di nuove istituzioni che vanno a sostituirne altre inadeguate oppure obsolete...
Un modo di intendere la storia pur utile, pur necessario ma che finiva per perdere di vista quell'insieme organico di relazioni e connessioni insieme sociali, economiche e psicologiche che "il tempo stenta a logorare e che porta con sé molto a lungo" (Braudel), da studiare non solo da un punto di vista statico, ma dinamico. Una concezione della storia che, come scrive Lucien Febvre, si deve praticare utilizzando "ciò che, appartenendo all'uomo, manifesta la presenza, l'attività, i gusti e i modi di essere dell'uomo" dove uomo sta per società umana, per gruppi organizzati.
È in tale direzione, sempre feconda di nuove scoperte, che si muove Roberto Pizzi, studioso da sempre sensibile alle manifestazioni artistiche e culturali, politiche e civili della Lucca laica: un campo d'indagine teso a valorizzare presenze se si vuole minoritarie ma tutt'altro che trascurabili nel secolare processo di definizione di un'identità collettiva e di una coscienza cittadina. In queste sue pagine lo studioso toscano, con la consueta acribia, prende in esame le più importanti espressioni socioeconomiche e tecniche che nel corso dei secoli hanno contrassegnato le manifestazioni più significative della vita della comunità lucchese e delle genti finitime della Piana, della Versilia e della Garfagnana: gli aspetti visibili e tangibili della loro storia e cultura, i materiali e gli strumenti concreti della vita quotidiana, senza trascurare gli effetti della loro ricaduta nella vita collettiva e nei luoghi in cui si è affermata e organizzata la socialità.
Diviso in tre parti – Prodotti del territorio: cibi e bevande; Industria e Artigianato; Tecnica e
Scienza - il libro di Pizzi è costruito per brevi saggi che, in veloci ed esaustive incursioni, studiano il punto d'impatto tra la dimensione locale e la materialità della vita quotidiana e delle attività produttive.
Nella prima parte, la sua attenzione per i celebrati "mangiari" lucchesi si insaporisce - è proprio il caso di dirlo - con la storia del vino, della birra, dell'olio, del castagno del riso del tabacco e del caffè e della loro, non sempre facile, affermazione sulle tavole e nei costumi degli abitanti della Città delle Mura e dintorni: il racconto, mai scontato e sempre agile e godibile, ricco di inedite vicende e inopinati protagonisti, di una "banalità della serenità" da praticare ancora, auspica l'Autore, il più spesso possibile sulla "base di elementi semplici e antichi, in fratellanza d'intenti" .
Oggetti della seconda sezione del libro sono: la carta e l'arte della stampa; la seta; la lana, gli altri prodotti tessili e le relative industrie lucchesi; l'invenzione del motore a scoppio di Barsanti e Matteucci e le sue conseguenze.
Più impegnativa la terza parte - Tecnica e Scienza - introdotta da un'ampia ed elaborata riflessione sui significati assunti dai due termini nel corso della storia umana e chiusa da un’ottimistica affermazione circa il valore emancipatorio di una ricerca scientifica ancora giovane eppure capace di sempre più straordinarie acquisizioni. Questo lo spirito con cui Pizzi si inoltra nel labirinto dei complessi rapporti tra "sapere" e "saper fare", contrapponendosi con tenace misura a quelle correnti regressive, manifeste e sotterranee, del recente pensiero occidentale sempre più ostili nei confronti della scienza e della tecnologia individuate come nemiche e distruttrici dell'umanità.
Per ricchezza d'informazioni, chiarezza espositiva e serena fiducia in una scienza intrisa di impegno civile e umana fraternità, anche i due capitoli finali Applicazioni scientifiche a Lucca e Storia del vaccino e della sua introduzione a Lucca, ben si connotano come modesti ma efficaci antidoti molecolari contro ogni irrazionalistica propensione ai medioevi prossimi venturi che sembrano incombere sugli abitatori di questi tormentati anni del nuovo secolo e del nuovo millennio.
Roberto Pizzi, Conoscere Lucca. Industria e prodotti del Territorio, Maria Pacini Fazzi editore, Lucca 2019, pp. 180, Euro 20,00
Roberto Pizzi svolge da anni un'intensa attività pubblicistica sui temi della storia locale.
Al centro dei suoi interessi una Lucca “di minoranza”, ma non per questo meno degna di attenzione e rispetto. Collabora con numerose pubblicazioni: “Documenti e Studi” semestrale dell'Isrec lucchese, “Actum Luce” e la “Rivista di Archeologia, Storia e Costume” dell'Istituto Storico Lucchese.
Tra i suoi libri ricordiamo: Squadre e Compassi della Lucchesia intorno all'Unità d'Italia, mpf 2011; La stampa lucchese dall'Illuminismo al Fascismo. Giornali, fatti, personaggi, mpf 2013; Conoscere Lucca. Storia e personaggi, mpf 2015
28 dicembre 2019
18 dicembre 2019
"Olè" di Raffaele De Bartolomeis
di Silvia Chessa
Al teatro
Petrolini, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 dicembre, è andato in
scena Olè, spettacolo scritto diretto ed interpretato da Raffaele De
Bartolomeis, il quale, in occasione del suo trentesimo di carriera, ha deciso
di festeggiare portando in scena, rivista e aggiornata, questa sua commedia
florilegio delle sue più efficaci battute e più iconici e riusciti personaggi.
Come suggerisce il
titolo - Olè – dettato dalle intenzioni (pienamente realizzate) dell’autore, la
cifra stilistica è la leggerezza indicata da Italo Calvino: quel “planare sulle
cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”, che non è banalità e contrasta la
pesantezza con l’arma comica e critica dell’ironia e della distanza.
Olè si struttura
così come uno scoppiettante e travolgente spettacolo, animato dalle musiche e
dalla carismatica presenza scenica di Pierfrancesco Galeri e deliziato, coreograficamente,
dalla grazia e professionalità della danzatrice Elena Frisenda.
Fra brillanti
trovate comiche, trasformismi talentuosi e veloci cambi di costume, poggiandosi
su una elegante e funzionale scenografia di Riccardo Polimeni, De Bartolomeis
trascina il suo pubblico alla risata sui soggetti più contemporanei (lo chef,
il medium, la rockstar) per poi accompagnarlo nel ricordo dei classici, con un
sentito tributo ai suoi maestri, da Totò a De Filippo, fra i quali spicca
l’omaggio a Troisi e Pino Daniele, particolarmente toccante ed emozionante.
Quasi due ore di
spettacolo che allietano e volano, in allegria e spensieratezza, nelle quali
l’autore-attore fa emergere la sua notevole capacità di tenere la scena e viva
l’attenzione del pubblico, chiamato a prendere parte attiva allo spettacolo,
che diventa, da one-man-show, anche una commedia partecipata in maniera
frizzante e spontanea.
11 dicembre 2019
" Verso l'infinito e oltre" di Nicola Barbato
Come per molti altri il mio "leopardismo" ebbe inizio sui banchi di un Liceo Classico: il Carducci di Viareggio, mezzo secolo fa. Cominciò con uno schierarsi d'istinto che il tempo avrebbe, kubrikianamente, portato "verso l'infinito e oltre”.
Tra mille altri passatempi assai meno colti, anche nelle nostre terze era in voga la disputa tra foscoliani e leopardiani ". Nel conflitto incruento tra liceali (guerra non di bottoni ma di poeti) non si poteva non prendere partito. Pena l'essere tacciati di ignavia.
I foscoliani rivendicavano la politicità radicale di Ugo e davano di Giacomo una lettura troppo intimista. Che gli idilli fossero quasi assimilati ai motti dei baci di cioccolata per innamorati peynettiani mi urtava. Non avevo letto, all'epoca, né Luporini né Timpanaro e l'illuminismo e il materialismo di Leopardi mi erano scolasticamente noti ma non conosciuti. A maggior ragione, poi, ne ignoravo la statura politica e perfino sociologica.
Quella contrapposizione, d'istinto, mi pareva artificiosa. E forse, a ripensarci, conteneva anche, tra le righe, un vago ammiccamento sessista (la politica come affare dei maschi, e Foscolo assurto a eroe "virile"). Mancava ancora un anno al fatidico 1968.
Io avevo iniziato (da poco) a occuparmi di politica ma proprio non sentivo rùggermi dentro nessuno "spirto guerrier" (per inciso e a scanso di equivoci: Alla sera è tra i sonetti che amo di più). La politica era un impegno pratico e una direzione di studio teorico. Non mi sembrava serio immaginarmi nei panni di un eroe risorgimentale solo perché mi affacciavo al presente in cui vivevo e ai suoi problemi. E dunque respingevo quella equazione tra politica e poesia foscoliana. Ma c'era di più. Diciamo che l'inquietudine esistenziale di Leopardi la sentivo mia, perché andava a scavare in una terra di interrogativi filosofici in cui già abitavo e a cui la politica non dava allora (oggi so che non può darle) risposte ristoratrici. Proprio perché l'essere "sconfitto da domande ancora aperte" mi ha accompagnato poi nei decenni, Leopardi era già per me il coraggio della coscienza (senza tuttavia che da quel coraggio nascesse - come per il Pericle riferito da Tucidide - la felicità).
Leopardi rappresentava la rinuncia a ogni consolazione preconfezionata ma, insieme, un antidoto alla passività. Era, il mio, un sentire ancora pre-Ginestra (anche questa l'avrei compresa tardi), un sentirsi fieri della propria singola, laica e deserta inconsolabilità. "L'infinito", nello splendore del suo plenilunio poetico, mi rapì, sul carro di una voce - quella di Arnoldo Foà - solo anni dopo. Ero ormai oltre i trenta e in piena crisi affettiva. La voce liberò il testo, sciolse il dolore rappreso, riuscì finalmente a consolarmi con la dolcezza delle lacrime, con la pacatezza densa di pause di quel timbro vocale inconfondibile. Piansi la scomparsa del poeta, e mi parve di piangere un fratello che avrei voluto vedere e toccare anche per un momento soltanto. Così l'infinito entrò per sempre dentro di me e nella mia memoria. Per molto tempo non ho potuto recitarlo fino in fondo, perché la voce mi si rompeva e dovevo zittirmi. Altre voci e altre musiche mi provocano effetti simili. Ma quella poesia è stata il mio "nuovo inizio".
In terza liceo amavo, sì, quella meraviglia di versi, ma preferivo "A Silvia". La innocente soccombente e ignara cantata dal poeta che pensa coraggiosamente, che sa fare oggetto di pensiero in versi il coraggio stesso. Forse mi spaventava l'idea di naufragare, sia pure dolcemente, in quel mare, troppo vasto, troppo infinito se così si potesse dire. Forse, a mio modo, resistevo all'idea del definitivo e irreversibile naufragio, a dispetto della esibita e titanica "inconsolabilità". C'è voluto del tempo per capire che il titanismo, in tutti i suoi travestimenti, è una semi obbligata epifania dei diciotto anni.
Oggi, duecento anni dopo, grazie alle nuove analisi ad altissima definizione, sappiamo ormai tutto di quel quaderno manoscritto e dell'incessante lavorìo di penna che ne ha preceduto la stesura definitiva. Ma questa è filologia. Radiografia. Anatomia, tavolo operatorio, dissezione. Lo splendore del plenilunio è un altro mondo. Un mondo infinito.
02 dicembre 2019
"Anche i Pisani sono esseri umani" di Luciano Luciani
Pagine da un libro d'improbabile pubblicazione
(prima puntata)
Pisa. L'ora del topo.
Arrivai a Pisa per la prima volta in una notte d'autunno di 47 anni fa. Mi ci condusse un treno improbabile: un localaccio in ritardo da Firenze, possibile destinazione Livorno, o magari Grosseto o forse anche La Spezia. Per me la Toscana, allora, era soprattutto Firenze e di lì ero convinto che si transitasse per andare da qualsiasi altra parte. All'atto della partenza da Roma l'idea di un collegamento diretto tra la Capitale e il capoluogo con la Torre pendente non mi aveva neppure sfiorato: così, complice anche una coincidenza sbagliata, allungai il viaggio di oltre due ore, mettendo piede, rintronato dal sonno, in una città appena uscita da un abbondante acquazzone notturno che aveva costellato di pozzanghere la piazza della Stazione e intasato più di un tombino. Mi accolse, dunque, una città acquitrino, mentre le nubi si diradavano, riapparivano le stelle e la luna faceva discretamente capoccella.
Era l'ora del lupo, o meglio del topo: unico essere vivente visibile, infatti, un ratto di chiavica di stazza medio-grande, incerto se attraversare o meno il viale che mi/gli si apriva davanti e alle prese, presumo, coi problemi della tana allagata. Emerso dalle fogne, si proponeva come esclusivo plenipotenziario del locale Comitato per le accoglienze: appena al di là della strada ne intuivo la pelliccia umida e ruvida di peli spinosi, la lunga coda, un'aria vagamente seccata. La stessa mia mentre affrontavo il problema di attraversare quel piazzale impaludato senza inzupparmi scarpe e calzini evitando inoltre di incrociare troppo da presso l'abitatore della cloaca e di quella primissima alba.
Una breve corsetta appesantita dalla valigia piena di libri e del tipo omnia mea mecum porto e guadagnai i portici senza garbo della pisana Galleria Gramsci. Dieci, quindici, venti passi ancora con le scarpe mézze (termine che nel 1972 non conoscevo e che avrei imparato a usare negli anni a venire) e... "Nessun eroismo" mi ribadii. Allora, modesto ma decoroso, un po' malinconico, mi offrì ospitalità l'Hotel La Pace: per circa tre settimane - nomen/omen - la mia prima residenza nella nuova città.
Pisa l'avevo appena appena sfiorata e l'impressione non era stata granché. Ignoravo che quel posto così poco accogliente, per oltre sette anni sarebbe diventata casa mia, intensamente vissuta e altrettanto amata e detestata.
Lavoro, non studio. Se Dio vuole, gli operai!
A Pisa non conoscevo nessuno e nessuno mi conosceva. Contrariamente a tanti miei quasi coetanei non arrivavo nella città toscana per frequentare i celebrati corsi di studio delle sue università. Un'onesta laurea in lettere moderne (il primo dei Luciani che si fosse mai addottorato!) l'avevo già conseguita l'anno precedente presso lo Studium Urbis: se mi ero mosso da Roma, dove ero nato e cresciuto e da cui raramente e sempre malvolentieri mi allontanavo, era per motivi di lavoro. Ero un insegnante. No, non un professore universitario, per carità. E neppure un docente di scuola secondaria di primo o secondo grado. E neanche un maestro elementare. No, io insegnavo nei Centri di Formazione Professionale, la misconosciuta figlia di un dio minore nel sistema di istruzione del Bel Paese. Ben più di oggi allora, quando le competenza in materia stavano faticosamente trasferendosi dal Ministero del Lavoro ai neonati Istituti regionali. Un settore già incoerente per via della pluralità dei soggetti che vi operavano - enti pubblici e privati; religiosi e sindacali; assistenziali e di pura speculazione - si trovava d'improvviso a dover ricontrattare tutto - sedi, strutture, finanziamenti, personale - non più con un solo interlocutore, ma con tanti quante erano allora le Regioni.
È in questa fase convulsa che l'Enaip (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale), per cui lavoravo presso il Cfp di Anzio Colonia (RM) - meccanici, saldatori, tornitori, disegnatori tecnici - in qualità di insegnante di cultura generale, accetta la mia domanda di trasferimento: nuova sede di lavoro, Pontedera, in provincia di Pisa e anche qui, vista la poderosa presenza della Piaggio, le stesse attività corsuali. Una promozione? A me, giovinotto, convinto, come molti del suo tempo, che, per immegliare il mondo, la classe operaia dovesse dirigere tutto, sembrava tale. In più da insegnante semplice ero stato promosso "coordinatore pedagogico", qualsiasi cosa volesse dire: di sicuro significava pochi soldi in più, nessun orario certo di lavoro e tante responsabilità extra, ma non m'importava. Quale migliore occasione di quella che mi veniva offerta per studiarli da vicino, conoscerli in carne, ossa e tuta blu, questi famosi operai sino a quel momento solo letti sulle pagine di Pratolini e Balestrini, portati sullo schermo da Gian Maria Volontè, cantati da Ivan Della Mea? Passavo dalla classe operaia dell'asse industriale Roma-Latina figlia dell'assistenzialismo della Cassa per il Mezzogiorno, clientelare e che votava a destra, ai solidi e politicizzati operai nel cuore della rossa Toscana.
(prima puntata)
Pisa. L'ora del topo.
Arrivai a Pisa per la prima volta in una notte d'autunno di 47 anni fa. Mi ci condusse un treno improbabile: un localaccio in ritardo da Firenze, possibile destinazione Livorno, o magari Grosseto o forse anche La Spezia. Per me la Toscana, allora, era soprattutto Firenze e di lì ero convinto che si transitasse per andare da qualsiasi altra parte. All'atto della partenza da Roma l'idea di un collegamento diretto tra la Capitale e il capoluogo con la Torre pendente non mi aveva neppure sfiorato: così, complice anche una coincidenza sbagliata, allungai il viaggio di oltre due ore, mettendo piede, rintronato dal sonno, in una città appena uscita da un abbondante acquazzone notturno che aveva costellato di pozzanghere la piazza della Stazione e intasato più di un tombino. Mi accolse, dunque, una città acquitrino, mentre le nubi si diradavano, riapparivano le stelle e la luna faceva discretamente capoccella.
Era l'ora del lupo, o meglio del topo: unico essere vivente visibile, infatti, un ratto di chiavica di stazza medio-grande, incerto se attraversare o meno il viale che mi/gli si apriva davanti e alle prese, presumo, coi problemi della tana allagata. Emerso dalle fogne, si proponeva come esclusivo plenipotenziario del locale Comitato per le accoglienze: appena al di là della strada ne intuivo la pelliccia umida e ruvida di peli spinosi, la lunga coda, un'aria vagamente seccata. La stessa mia mentre affrontavo il problema di attraversare quel piazzale impaludato senza inzupparmi scarpe e calzini evitando inoltre di incrociare troppo da presso l'abitatore della cloaca e di quella primissima alba.
Una breve corsetta appesantita dalla valigia piena di libri e del tipo omnia mea mecum porto e guadagnai i portici senza garbo della pisana Galleria Gramsci. Dieci, quindici, venti passi ancora con le scarpe mézze (termine che nel 1972 non conoscevo e che avrei imparato a usare negli anni a venire) e... "Nessun eroismo" mi ribadii. Allora, modesto ma decoroso, un po' malinconico, mi offrì ospitalità l'Hotel La Pace: per circa tre settimane - nomen/omen - la mia prima residenza nella nuova città.
Pisa l'avevo appena appena sfiorata e l'impressione non era stata granché. Ignoravo che quel posto così poco accogliente, per oltre sette anni sarebbe diventata casa mia, intensamente vissuta e altrettanto amata e detestata.
Lavoro, non studio. Se Dio vuole, gli operai!
A Pisa non conoscevo nessuno e nessuno mi conosceva. Contrariamente a tanti miei quasi coetanei non arrivavo nella città toscana per frequentare i celebrati corsi di studio delle sue università. Un'onesta laurea in lettere moderne (il primo dei Luciani che si fosse mai addottorato!) l'avevo già conseguita l'anno precedente presso lo Studium Urbis: se mi ero mosso da Roma, dove ero nato e cresciuto e da cui raramente e sempre malvolentieri mi allontanavo, era per motivi di lavoro. Ero un insegnante. No, non un professore universitario, per carità. E neppure un docente di scuola secondaria di primo o secondo grado. E neanche un maestro elementare. No, io insegnavo nei Centri di Formazione Professionale, la misconosciuta figlia di un dio minore nel sistema di istruzione del Bel Paese. Ben più di oggi allora, quando le competenza in materia stavano faticosamente trasferendosi dal Ministero del Lavoro ai neonati Istituti regionali. Un settore già incoerente per via della pluralità dei soggetti che vi operavano - enti pubblici e privati; religiosi e sindacali; assistenziali e di pura speculazione - si trovava d'improvviso a dover ricontrattare tutto - sedi, strutture, finanziamenti, personale - non più con un solo interlocutore, ma con tanti quante erano allora le Regioni.
È in questa fase convulsa che l'Enaip (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale), per cui lavoravo presso il Cfp di Anzio Colonia (RM) - meccanici, saldatori, tornitori, disegnatori tecnici - in qualità di insegnante di cultura generale, accetta la mia domanda di trasferimento: nuova sede di lavoro, Pontedera, in provincia di Pisa e anche qui, vista la poderosa presenza della Piaggio, le stesse attività corsuali. Una promozione? A me, giovinotto, convinto, come molti del suo tempo, che, per immegliare il mondo, la classe operaia dovesse dirigere tutto, sembrava tale. In più da insegnante semplice ero stato promosso "coordinatore pedagogico", qualsiasi cosa volesse dire: di sicuro significava pochi soldi in più, nessun orario certo di lavoro e tante responsabilità extra, ma non m'importava. Quale migliore occasione di quella che mi veniva offerta per studiarli da vicino, conoscerli in carne, ossa e tuta blu, questi famosi operai sino a quel momento solo letti sulle pagine di Pratolini e Balestrini, portati sullo schermo da Gian Maria Volontè, cantati da Ivan Della Mea? Passavo dalla classe operaia dell'asse industriale Roma-Latina figlia dell'assistenzialismo della Cassa per il Mezzogiorno, clientelare e che votava a destra, ai solidi e politicizzati operai nel cuore della rossa Toscana.
28 novembre 2019
"Le teste di carattere" di Franz Xaver Messerschmidt
nota di Silvia Chessa
Le teste di carattere, o Koepfe di Franz Xaver Messerschmidt (Wiesensteig,
6 febbraio 1736 – Presburgo, 19 agosto 1783): una scoperta tardiva e scioccante
della particolare arte di questo scultore, perseguitato dai demoni notturni, i
demoni delle proporzioni, ai quali, in una lotta impari e disperata, cercò di strappare
il segreto che solo Dio detiene, ed ottenne di ricreare, almeno, in una
sessantina di allucinanti busti, nei becchi umani distorti e allungati allo
spasimo, lo sforzo immane di quella ricerca e delirante battaglia, personale e
artistica.
Un caso lampante di Èudamonìa, o buona riuscita dei propri
dèmoni.
18 novembre 2019
"Piccoli racconti di misoginia" di Patrice Highsmith
Il
primo racconto troppo lineare. Il
secondo migliore, ma scontato. “Che cosa ha fatto Patricia Highsmith?” penso. “Si
è concessa una vacanza?”.
Invece via via che leggo i racconti prendono forza
fino a trovarne alcuni indimenticabili. Da diventare una trance de vie. Un po’ come succede in Giuseppe Pontiggia nei suoi
racconti Vite di uomini non illustri.
I
più belli sono: La donna oggetto, La puritana, La fattrice potente nella sua iperbolica e grottesca vicenda.
Il
campionario di donne che emerge, in questi diciassette racconti, è terribilmente
feroce, da una ferocia quasi matematica,
da teorema pasoliniano. E’ come se Patricia Highsmith ci dicesse che non sempre
i fatti della vita sono complessi o meglio che esiste una complessità lineare, cioè
ripetitiva.
In altri termini queste donne sembrano segnate da un destino. Non si inventano. Sono quelle che sono: finte invalide, vere assassine, mitomani, fatue, fanatiche, ossessionate, vittime, carnefici.
Patricia Highsmith. Piccoli racconti di misoginia. Bompiani
01 novembre 2019
"Questo il futuro che ci aspetta?" di Luciano Luciani
Giovani versus capelli bianchi
Conoscete lo scrittore Antonio Manzini? È il romanziere che ha inventato il personaggio del vicequestore Rocco Schiavone, magistralmente portato sul piccolo schermo dall'attore Marco Giallini.Prima di raccontarci le avventure del suo stropicciato “eroe indagatore”, Manzini aveva scritto un libro, per tanti versi inquietante, intitolato La giostra dei criceti nelle cui pagine si ipotizza che importantissimi esponenti del nostro apparato statale concepiscano un piano, denominato “Anno Zero”, per abbattere un debito pubblico pericolosamente alle soglie del default finanziario. Un progetto tanto semplice quanto feroce: moltiplicare le dipartite degli anziani fruitori di pensione e così alleggerire la voce relativa alle spese sociali nel bilancio nazionale.
Distopie fantapolitiche? No davvero! È notizia recente che un noto leader politico, già di professione attore comico (in verità meno che mediocre) riciclatosi come demagogo forsennato, abbia individuato un nuovo nemico da indicare alla sempre più numerosa specie degli odiatori seriali e sociali: gli anziani, parassiti della società da privare quanto prima del diritto di voto. Ecco, dopo i disgraziati sui barconi ora abbiamo un nuovo avversario da combattere: le donne e gli uomini coi capelli bianchi che con i loro trattamenti pensionistici farebbero mancare ai giovani i mezzi necessari per garantirsi un futuro dignitoso.
Invece di prendersela con i veri detentori della ricchezza e quindi del potere - che so, per non parlare del solito Berlusconi mi vengono in mente i “paperoni” Luigi del Vecchio, patron di Luxottica: Giovanni Ferrero, il re della Nutella; Giorgio Armani, il più stilista tra tutti gli stilisti e via miliardeggiando... - il nostro arruffapopoli non trova di meglio che favorire un'altra frattura all'interno della società italiana: quella generazionale e dunque giovani contro vecchi. E così, oltre alla modestia degli emolumenti mensili erogati - 5,8 milioni di pensionati godono (si fa per dire!) di redditi da pensione inferiori o pari a 1000 euro - , agli acciacchi propri dell'età, a un sistema sanitario sempre più arcigno, al progressivo diradarsi delle gioie della vita e delle speranze, alle rughe sul viso e nello spirito, ora, dopo la livida lezione di un politico rancoroso, amplificata ad arte dai social media (si dice così?) i seniores dovranno imparare a guardarsi anche da figli e nipoti sempre più maldisposti verso quanti sono percepiti come i depositari di ogni bene materiale. Oggi da privare dei diritti elementari, domani chissà... Avversari da sterminare quanto prima per dividersi il bottino prima di entrare - cosa che prima o poi tocca a tutti - nel cono d'ombra della senilità.
Le uscite estemporanee del cinico e attempato Pennywise nostrano, oggi in grave difficoltà negli accidentati territori della politica italiana, non meriterebbero neppure una risposta se considerazioni pericolosamente simili non fossero apparse anche nella Gran Bretagna della Brexit e nell'America di Donald Trump. Dobbiamo cominciare a preoccuparci? Intanto ci torna in mente una considerazione del pittore e scrittore Mino Maccari: “È pericoloso dare gratis ai giovani molte cose che costarono carissimo ai più anziani”.
30 ottobre 2019
“Il volto dell’amore” di Flavio Caroli
di Gianni Quilici
Flavio Caroli, è stata
una delle scoperte, a beneficio del
grande pubblico, di Fabio Fazio. Scoperta benefica, perché ci troviamo di
fronte ad un critico colto e acuto, appassionato e desideroso di comunicare con
il pubblico e con la capacità di saperlo
fare.
Leggo “Il volto
dell’amore”, e senza essere un critico d’arte, ne traggo benefici.
Perché?
Primo: Caroli ama
delineare percorsi nella pittura, che, attraverso un tema, in questo caso
l’amore, consentano di creare un filo che collega tra loro, con le loro
specificità e differenze, secoli, correnti, pittori, senza ignorare, peraltro,
la letteratura e il teatro.
Secondo: l’amore viene trattato da Caroli nelle infinite possibilità in cui esso si può esprimere: dalla sensualità gaudente pagana degli affreschi pompeiani a quella introspettiva di Leonardo da Vinci, che non solo rappresenta, ma interpreta la psicologia dell'amore; dall’amore sacro e familiare del Cinquecento all'amore naturale della pittura seicentesca e settecentesca; dall'erotismo lieve e carnale di Antonio Canova a quello magico e intenso di Francisco Goya; dal romanticismo risorgimentale di Francesco Hayez all'ossessivo tentativo di cogliere l'invisibile attraverso il visibile di Edgard Degas.
Alcuni dei
percorsi segnano le tappe di un viaggio che vedrà le sue colonne d'Ercole sulla
soglia del XX secolo, quando l'inconscio freudiano entrerà con prepotenza nella
cultura occidentale.
Terzo: in questo
percorso Flavio Caroli sceglie alcune opere, che a suo giudizio possono essere
paradigmatiche, analizzandole con l’occhio di chi sa cogliere la complessità nei suoi aspetti molteplici: storici, formali
e di senso.
Quarto: Tutto questo consente al lettore, e al critico, una partecipazione attiva: di aggiungere o di tagliare, di polemizzare o di ampliare, perché Caroli ha il merito da una parte di essere esplicito nelle sue scelte e nei suoi giudizi; dall’altro di lasciare, anche a se stesso, la curiosità di giocare creando nuovi itinerari dentro la storia dell’arte, come ha continuato a fare con altri libri. Non soltanto uno storico dell’arte rigoroso, ma anche giocoso, aperto e, per certi versi, smisurato.
Flavio Caroli. Il
volto dell’amore. Oscar Mondadori. 2011.
.
29 ottobre 2019
"Lucca 1968: la cultura del movimento" di Gianni Quilici
Uno degli articoli tratti dal libro "E la vita cambiò - Il '68 a Lucca-"
di autori vari. Carmignani Editrice
Che senza gli anni
’60 non ci sarebbe stato il ’68 è una banalità, tanto il pensiero è scontato. E’
soprattutto, infatti, a partire dagli anni ’60, che irrompe quel vento libertario
che investe classi sociali e costumi, cultura e linguaggi fino ad invadere la
politica. Anzi, si può dire che il vero '68 sono gli anni 60, compreso
naturalmente il biennio 1968-69. Perché sono gli anni esistenzialmente più
complessi, perché più aspro è stato il conflitto repressione-liberazione,
perché la prima ondata di liberazione non è stata per niente legata a ideologie
ossificate, perché anche il linguaggio è stato messo in discussione in
molteplici modi e con una radicalità, che non è diventata però formalismo.
Per non farla
troppo lunga, facciamo un esempio: il cinema.
Dagli inizi degli anni ‘60 esplode, infatti, un’ondata di film che
rompono con il passato: il Free Cinema inglese e il cinema underground, la nouvelle
vague francese e il nuovo cinema italiano, il cinema novo brasiliano e i film della New Hollywood. Ecco emergere nuovi
registi scandalosi e provocatori, visionari o anche sgrammaticati: Cassavetes e
Mekas, Rocha e Oshima,
Godard e Truffaut, Resnais e Rohmer, Fellini e Antonioni, Bellocchio e Bertolucci, Pasolini
e Carmelo Bene e tanti altri ancora. E così si potrebbe dire per la musica, per
le arti figurative, per il teatro, per il giornalismo, per la letteratura.
 |
| Primo scipero studentesco a Lucca |
E tuttavia il
movimento studentesco, che scoppiò impetuosamente e improvvisamente anche a
Lucca, ha alle spalle un retroterra culturale modesto, prodotto di una società
conformista, dove domina una cultura cattolico-democristiana e una scuola
selettiva e classista che reprime creatività e partecipazione. Certo esistono
in città punte avanzate, soprattutto individuali, nella musica e nella letteratura, nella
pittura e nel cinema, ma circoscritte al centro storico in un ambito sociale di media e piccola borghesia.
Ci sono tuttavia
alcuni avvenimenti politici internazionali e nazionali e correnti di pensiero, che agiscono
sotterraneamente in coloro che
frequentano le Università e anche in alcuni che saranno protagonisti del
’68 lucchese. In sintesi:
1) la guerra di
popolo dei vietcong, che, in modo imprevedibile, oltre ogni logica di rapporti
di forza, sconfigge la grande potenza
economico-militare degli Stati Uniti;
2) la presenza di
esperienze cattoliche avanzate, come conseguenza del Concilio Vaticano II, e la
grande influenza che avrà la pubblicazione di Lettere
ad una professoressa di Don Milani;
3) la presenza di
un’avanguardia sindacale e operaia anche a Lucca, legata alla rivista dei Quaderni Rossi, che si sta organizzando
nelle fabbriche più grandi del territorio;
4) il movimento
dei beat lucchesi, che paradossalmente vive a Lucca una delle esperienze culturali
più vive e avanzate e che per le qualità culturale e l’impatto provocatorio dei suoi leader agisce profondamente
nell’immaginario giovanile e non solo.
La stragrande
maggioranza degli studenti, che parteciperà ai movimenti del 1968-69 è però, a
differenza di Pisa, formata, in gran parte, da studenti medi, ragazzi e
ragazze giovanissimi, senza bagagli
culturali alle spalle e che scoprirà in quei mesi e in quegli anni le sue
ideologie e il suo immaginario, le sue letture e i suoi maestri.
Ben presto su
tutti dominerà la triade, tante volte gridata come slogan dei cortei, Marx,
Lenin e Mao Tse Tung. Di Marx si legge soprattutto Il manifesto del partito comunista”, di Lenin il Che fare? e Stato e rivoluzione, di Mao Il
libretto rosso e opuscoli specifici del suo pensiero. Sono letture molto
ideologiche, non collocate nel contesto di un capitalismo avanzato, che muterà progressivamente
e rapidamente condizioni di vita, classi
sociali, consumi e culture. Pochi di loro leggono e utilizzano i Quaderni dal carcere di Gramsci,
necessari per capire la specificità italiana ( la formazione dello Stato e la
questione cattolica e meridionale, la forma del Partito e il concetto di
egemonia). Ancora meno vengono letti Marcuse e i filosofi della Scuola di Francoforte,
che avevano studiato quelle società di tardo capitalismo, di cui entrava a far
parte anche l’Italia. Colpisce, invece, e colpirà sempre di più l’immaginario la
vita politicamente avventurosa di Ernesto Che Guevara, la sua idea di
rivoluzione permanente e la necessità di creare un “Hombre nuovo” e la sua
immagine riprodotta in un manifesto farà
il giro del Pianeta ed è tuttora una delle icone simbolo del ‘900.
Molto importante
è la musica, come molti interventi hanno
qui nel libro sottolineato. Perché la musica ha un’immediatezza in sé che la
parola e l’immagine non possono avere. E quindi sia le canzoni dei cantautori
nostrani da Guccini a Fabrizio De Andrè che quella gioiosa, rivoltosa,
profetica che arrivava dai Beatles e dai Rolling Stones, dai Pink Floyd e Bob
Dylan rappresentavano una visione del mondo “altra” rispetto al conformismo
censorio e mortifero dell’Italia dominante.
Non fanno, invece
parte dell’immaginario e del dibattito lucchese, il cinema e la letteratura,
che rimangono consumi privati, non sono oggetto ne’ di dibattito (se non in
casi ristretti), ne’ soprattutto di attività produttive. Non ci sono a Lucca
romanzi, racconti, poesie in quegli anni, non ci sono filmati e, purtroppo, non
ci sono neppure foto, se non pochissime e casuali.
Certo c’è chi
continua a leggere individualmente. E’ sempre vivo il mito on the road di Jack Kerouac e l’urlo
di Allen Ginsberg, intriga l’erotismo vitalistico di Henry Miller o
l’avventura mistica di Herman Hesse e forse anche la testimonianza intima del Mestiere di vivere di Cesare Pavese.
Vale un discorso
simile anche per il cinema. Prima durante dopo il 68 escono film, molto diversi
tra loro, che rappresentano i sentimenti e l’atmosfera di quegli anni: la
rabbia e la fuga, il viaggio e la rivolta,
la lotta e i mutamenti di costume e di linguaggio. Film, molto diversi tra loro:
Pugni in tasca, Fragole e sangue, Cinque
pezzi facili, Woodstook, Easy Reader, If, Antonio Das Mortes, Blow up, “Teorema,
Porcile, ,Zasbrinski Point, 2001 Odissea
nello spazio, Nostra signora dei turchi, Grazie zia. Mash, Festa per il
compleanno del caro amico Harold, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni
sospetto, Z l’orgia del potere, 12 dicembre e tanti altri. Alcuni di questi
film sono stati certamente visti dai “giovanissimi sessantottini”, ma non hanno
avuto spazio alcuno a livello pubblico come strumenti di riflessione e di
confronto.
Forse l’unico
personaggio che si impone, sicuramente nel dibattito nazionale, e, nei suoi
limiti municipali, anche a Lucca, è Pasolini. Il regista-poeta-polemista,
infatti, ha il coraggio e l’intelligenza sociologica da una parte di essere
solidale con il movimento (realizzerà per Lotta Continua il film 12 dicembre), ma insieme di essere molto
critico con la famosa poesia sugli scontri polizia-studenti di Valle Giulia a
Roma. A rileggerla a distanza di tempo oggi, al di là della modestia prosaica dei versi
riconosciuta dall’autore stesso, va riconosciuto che Pasolini coglie alcuni dei
limiti antropologici, oltre che culturali, del movimento stesso.
In realtà in
quegli anni tutte le energie ( o molte di esse) vengono concentrate
nell’attività politica. La politica viene a coincidere, infatti, in buona parte
con la vita, perché dentro la politica non ci sono soltanto riunioni,
volantinaggio, assemblee, ci sono anche i rapporti interpersonali,
sentimentali, sessuali. E c’è infine la propria identità in gioco in un
confronto-scontro in divenire. C’è poco tempo per leggere o per scrivere, se
non per ciò che riguarda strettamente la politica.
27 ottobre 2019
"Voglio ringraziare Jack" di Maurizio Della Nave
Nel 1970 avevo 14 anni e durante quel
novembre per caso ascoltai i miei primi due LongPlaying, “The Piper at the
Gates of Dawn” ed “Atom Hearth Mother” dei Pink Floyd. Neppure un mese dopo mi
capitò tra le mani una copia di “Sulla strada” di Jack Kerouac.
Quei due dischi li riascoltai spesso, talvolta mentre percorrevo il mio primo viaggio attraverso quelle pagine di Jack. Durante gli anni successivi ascoltai molti altri dischi e lessi molti altri libri, sempre seguendo un fiume in piena di emozioni e lentamente scoprendo mondi meravigliosi; qualche anno dopo avevo 19 anni e quel libro di Jack iniziò a dormire sotto la mia testa durante le mie prime lunghe fughe in autostop…
Forse, se non avessi ascoltati quei due dischi, se non avessi letto quel libro, se non avessi intrapreso mille viaggi attraverso tutte le direzioni che incontravo, adesso la mia immaginazione e la mia mente creativa non sarebbero state le stesse.
Dunque voglio ringraziare Jack. Certo, non solo lui, ma lui con quello e gli altri suoi libri ha dato il via al mio personale viaggio che sta ancora continuando crescendo esplorando… Un percorso che, lasciando poi Jack ed i suoi amici in lontananza, ha attraversato una manciata di anni, quei ’70 che mi hanno trovato troppo piccolo per il ’68 e forse un po’ grande per il ’77 e che mi hanno catapultato nel fantastico caos musicale e artistico degli ’80. Non avrei potuto desiderare o immaginare niente di più fantastico esaltante emozionante irripetibile sconvolgente! (Thanks a lot, life!)
Dunque voglio ringraziare Jack e molti altri, per avermi accompagnato,
e devo ringraziare anche me per aver saputo ben camminare attraverso tutti quei
mondi, senza troppi errori e con la capacità di accogliere esperienze con
discernimento e profonda attenzione, tuttora assieme a tutte quelle musiche e
tutti quei libri che si fanno sentire nella mia testa mentre vivo amo lavoro
cammino creo osservo ascolto e poi tutto il resto…
"L'operetta italiana" di Luciano Luciani
Accompagnano l'ascesa del fascismo le melodie dell'operetta italiana
Piuttosto appannato oggi il fascino dell'operetta, la “piccola lirica” che nella stagione più piena del grande melodramma ottocentesco cominciò ad alternare brani musicali, danze e parti dialogate: forse ci appaiono troppo rosati, evasivi e fiabeschi i suoi temi poco adeguati ai tempi complicati e difficili con cui ci troviamo quotidianamente a dover fare i conti.A partire da La rose de Saint-Flour di Jacques Offenbach, 1856, le melodie di questo nuovo genere teatrale, specchio della società borghese di cento e passa anni fa, una Belle Époque carica di attese ottimistiche, accarezzano ancora piacevolmente l'orecchio, nonostante l'irrimediabile caduta di tante aspettative, di tante attese ottimistiche sorte in tutta Europa tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del secolo scorso.
Una meteora luminosa e breve l'operetta, legata a particolarissime condizioni, piuttosto rapida la sua stagione. Però, le immagini che evoca hanno i colori vividi e smaglianti e gli scenari suntuosi di un'età che noi per primi, con forza, vogliamo spensierata e felice, popolata com'è di aristocratici ricchissimi, di località amene, di scenari ridenti, di amori mai del tutto impossibili, di problemi dinastici o politici mai irrisolvibili...
Esemplare in tal senso risulta l'operetta italiana Il Paese dei Campanelli, 1923, tarda declinazione nostrana di un genere ormai in decadenza nel resto d'Europa, progressivamente sostituito dal teatro di varietà e dalle prime commedie musicali.
E così, mentre gli italiani assistono impotenti agli ultimi sussulti dello Stato liberale e si consumano, una a una, le residue garanzie della democrazia parlamentare asfissiata dal fascismo incombente, niente di più evasivo - e comodo - che raccontare di una località favolosa, situata più o meno dalle parti dell'Olanda, dove campane e campanelli hanno il vezzo di cominciare a suonare ogni qualvolta che mogli e fidanzate sono sul punto di tradire i loro uomini...
Una fiaba scritta dal librettista Carlo Lombardo e svolta musicalmente, con garbato gusto liberty, dal maestro Virgilio Ranzato, violinista alla Scala di Milano con Toscanini e concertista di fama. La prima del Paese dei Campanelli, si tiene al Teatro Lirico di Milano il 23 novembre del 1923: il giorno 13 dello stesso mese il Senato aveva approvato a ristrettissima maggioranza la nuova legge elettorale che aboliva la rappresentanza politica proporzionale e reintroduce il sistema maggioritario.
Ma nell'operetta, si sa, non c'è la tragedia della storia, non compaiono mai o sono solo appena accennati i drammi dell'esistenza: a volte vi circola un po' di nostalgia, un lieve palpito di malinconia per il tempo che passa, per la giovinezza e la bellezza che ci sfuggono.
Due anni più tardi i due massimi esponenti dell'operetta tricolore, appunto Lombardo e Ranzato, tentano di bissare il successo ottenuto con Il Paese dei Campanelli. Ed ecco, per un pubblico in vena di facili esotismi, la storia di Cin-Ci-Là, bella e navigata attrice francese che, in quel di Macao, tra mille equivoci maliziosi, riesce a portare a termine l'educazione sentimentale del principe Ciclamino e di Myosotis, sua promessa sposa e fidanzata inesperta. Nozze finali e allegre feste in tutta Macao:
O Cin-Cin-Là
O Cin-Ci-Là,
mordi, rosicchia, divora,
tormenta pure chi ti vuol bene,
le tue catene son fatte di fior!
Ma ben altre sono le catene che si preparano per il popolo italiano. Il 26 dicembre 1925, una settimana dopo la prima milanese di Cin-Ci-Là al teatro Dal Verme, viene varata una legge sulle prerogative del capo del governo, Benito Mussolini, responsabile della propria azione politica solo di fronte al re, l'unico che lo può dimettere. Le Camere sono esautorate. Nello stesso giorno un decreto stabilisce che i funzionari pubblici che non diano piena garanzia di adempimento dei loro doveri o si pongano in condizione di incompatibilità con le direttive generali del governo possono essere licenziati.
02 ottobre 2019
"Vocabolario Bagaladese" di Francesco Antonio Romeo
LA FORZA DELLE PAROLE
di Luciano Luciani Tra gli alfabetizzati solo una minoranza scrive: poesie e memorie autobiografiche, racconti e romanzi... Ma un vocabolario, e per di più dialettale, è cosa rara e notevole. Francesco Antonio Romeo, “Ciccio” per familiari e amici, dopo una vita trascorsa in mezzo ai libri, - ha lavorato per quarant'anni presso la Biblioteca Universitaria di Pisa - finalmente in pensione, ha deciso di scriverlo anche lui un suo libro.
E come argomento ha scelto proprio quello di cui i libri, il materiale della sua professione, sono pieni, ovverosia le parole: per salvarle. perché nelle parole, - vocaboli e verbi, proverbi e modi di dire, nomi, toponimi e soprannomi - lì dentro, ci siamo noi: la nostra storia, il passato, il presente e anche il nostro futuro.
E siccome custodirle tutte risultava un po' troppo impegnativo, “Ciccio” ha scelto di tutelare almeno quelle della sua lingua nutrice, il dialetto di Bagaladi, 460 metri slm 1025 abitanti, suo paese d'origine in provincia di Reggio Calabria. Le ha raccolte, le parole, con la pazienza certosina adeguata alla bisogna e con il rigoroso senso dell'ordine proprio della sua attività quarantennale. Non da solo, ma - e questo merita di essere sottolineato - con un agire collettivo, aperto al nuovo e alla contemporaneità: il “gruppo facebook” A Bagaladi parramu così che lo ha aiutato non poco nella ricerca.
È stato costruito così il Vocabolario Bagaladese / Bagaladese-Italiano Italiano-Bagaladese, che nasce dalla necessità, acutamente sentita da questo appassionato estimatore della cultura locale, di documentare le trasformazioni intervenute nel dialetto della sua terra: valorizzare le palore abbandonate, quelle che si riferiscono a oggetti e situazioni della tradizione ormai sostituite dai modi di vivere attuali, e mettere il luce le parole nuove, quelle della contemporaneità, rimodulate in dialetto.
Scorrendolo, questo vocabolario, si ha come l'impressione di un intreccio di passato e presente, di ieri e di oggi... Succede che maturando, invecchiando, tutti noi, come accade all'Autore, diventiamo un po' nostalgici e un po' conservatori: di un altro tempo destinato a non tornare più, e anche delle sue parole. E quindi, come hanno fatto tanti prima di noi, scriviamo versi, elaboriamo storie, mettiamo sulla carta la nostra versione dei fatti accaduti allora...
Di sicuro quelle stagioni lontane, “povere ma belle” - ma per chi c'era soprattutto povere – non furono felici e neppure particolarmente serene. Furono, però, piene di “senso”, che è proprio quello che più ci manca oggi in questi nostri giorni intrisi di smemoratezza, cattiveria e violenza. Contro questo deficit, chi ha ancora voglia e forza continua a battersi con le armi della razionalità, della giustizia, della conoscenza di cosa è giusto e cosa sbagliato. Sempre dolorosamente consapevole che “la maledizione degli uomini è che essi dimenticano”, ma altrettanto cosciente che un antidoto efficace contro una tale condanna è quello di provare, intanto, a salvare le parole e magari, perché no, a inventarne di nuove.
Francesco Antonio Romeo, Vocabolario Bagaladese / Bagaladese-Italiano Italiano-Bagaladese, Città del Sole Edizioni, Reggio Calabria 2019, pp. 192, Euro 18.00
25 settembre 2019
"Novy Mir" di Enzo Guidi
di Gianni Quilici
“E’
un romanzo avvincente che crea subito dall’inizio una tensione narrativa, uno
sviluppo avventuroso, una conclusione imprevedibile e aperta, che suscita il
desiderio di leggere il romanzo anche semplicemente come pura storia.
E’ un romanzo complesso a partire dal
protagonista, Riccardo Bruni, nevrotico e lucidissimo nel suo perenne
interrogarsi, poetico e indifeso, che viene inghiottito e, per certi versi,
manipolato da una organizzazione russa potentissima e misteriosa sulla base di
una promessa: il successo planetario di alcuni dei suoi romanzi.
E’ un romanzo anche filosofico, di una
filosofia tanto antica quanto contemporanea, che in “Novy Mir” si spinge oltre:
sperimentare la possibilità per un uomo di assimilare una coscienza vegetale,
sentire e sentirsi, cioè, come se si incarnasse in una pianta.
E’ quindi anche un romanzo originale, perché
ci trasporta da un possibile incubo kafkiano dell’oggi ad una possibile utopia:
allargare la nostra coscienza, oltre l’umano, in cui l’individuo perde la sua
centralità sapendo di essere vita nella vita
.
E’ infine un romanzo scritto con lo stile di
un vero scrittore: onirico e realistico, tenero e sarcastico, tagliente e
fluente”.
Enzo Guidi. Novy Mir. Edizione ETS.
16 settembre 2019
"Quella volta che il Volto Santo rise" di Franco Fantozzi
Uno scanzonato - ma non troppo - private eye di provincia
di Luciano LucianiAllora la Città Murata può vantare ancora un altro “sceriffo”, ovvero l'ennesimo eroe indagatore che, vuoi per soldi, vuoi per un'apprezzabile etica professionale, non può sopportare che il Male si aggiri per le strade e le piazze di Lucca e nei suoi immediati dintorni. Non è un poliziotto e nemmeno un carabiniere, neanche un giornalista e neppure un magistrato: è un private eye, un investigatore privato, mestiere più adatto a scenari metropolitani che a città di provincia al di sotto dei centomila abitanti. Però, i fattacci - ve lo siete già dimenticato il Mostro di Firenze? - accadono anche in Toscana e i suoi misteri, le sue trame efferate, i suoi feroci primi attori non sfigurano di sicuro con i truci protagonisti degli scenari mega-urbani di Roma, Milano, Parigi o Londra...
Certo, la storia noir in salsa lucchese, sia pure abilmente elaborata dall'Autore, mantiene fin troppo riconoscibili sapori locali che però, per dirla come si usa da queste parti tra il Serchio, le Apuane e il mare, non “stuccano” perché fanno identità e sollecitano l'appartenenza. Così, non ci disturbano il gergo indigeno di Frenk, il protagonista in scena dalla prima all'ultima pagina che racconta in prima persona; certi giochi di parole un po' insistiti; location alquanto risapute e riferimenti a fatti e personaggi noti solo agli autoctoni e per di più di una certa età.
La novità di queste pagine sono altre e riscattano a pieno certi eccessi di tipicità: per esempio, le doti ESP (extra sensory perception) del Nostro investigatore privato. Ovvero, i suoi personalissimi canali di informazione estranei alla scienza e fuori da ogni metodo scientifico: Frenk Maniscalchi, infatti, titolare della rinomata Agenzia Frenkenson, ormai oltre la mezza età e già nonno di nipoti grandicelli, parla con la gatta Lucrezia, tutt'altro che avara di dritte utili per la soluzione dei casi, anche se piuttosto sibilline, e, udite,udite, conversa niente meno che col Volto Santo, il Cristo nero e ligneo conservato nel duomo di San Martino e da quasi un millennio venerato dai Lucchesi e non solo. Se, poi, a tali formidabili aiutanti dell'eroe ci aggiungete il servizio informazioni garantito dalla Similanza, una simpatica banda di drop out che agisce sempre in bilico sul sottile confine tra legalità e illegalità, anche il più scettico dei Lettori, oltre a essere conquistato da questa storia “al limite” tra ironia e dramma, non potrà nutrire dubbi circa la necessaria vittoria del Bene sul Male, dell'onestà sul crimine.
Così, nei canonici tre giorni - tempo limite datosi dal Maniscalchi per la soluzione di tutti i suoi casi – il Nostro, lucense incarnazione dell'indimenticabile, ma meno simpatico, Hercule Poirot, risolve il difficile caso della morte enigmatica e violenta di un noto industriale dolciario produttore del rinomato in tutto il mondo Brucellato Delight. Trionfa, come si conviene a ogni buon poliziesco, la verità, ma lo sguardo che questa vicenda permette di gettare sui nostri tempi malmostosi non è per nulla consolante: antiche pulsioni, il denaro, la gelosia, il potere, il tradimento, si coniugano secondo nuove modalità. L'Autore, travestito da intrattenitore, le registra e prova a individuarne le oscure motivazioni: non tragga in inganno la sua maschera cordiale, bonaria, ottimista...
Serpeggia tra le pagine, apparentemente disincantate, tutta la fatica che costa cercare di tenere a bada il caos. Frenk Maniscalchi per farlo usa le armi che può, che sa, quelle proprie degli uomini: la razionalità, un innato senso di giustizia, la conoscenza di cosa è sbagliato, una profonda pietas... Questa particolare battaglia la vince, ma, ne siamo sicuri, altre ne verranno, più sode, puntute, taglienti.
Franco Fantozzi, Quella volta che il Volto Santo rise, Carmignani editrice, Pisa 2019, Euro 13,00
05 settembre 2019
“Il tuffo” di Fernando Herráez
nota di Gianni Quilici
Due elementi colpiscono in questo scatto
del fotografo spagnolo Fernando Herráez. Due elementi,
che nel loro contrasto si armonizzano, perché rendono la foto più complessa
formalmente e nei suoi possibili sensi e, per chi la osserva con attenzione, forse
indimenticabile.
Sulla sinistra vediamo un ragazzo colto
sospeso nell’attimo in cui si tuffa, le mani protese verso l’impatto con
l’oceano, le gambe ancora piegate dallo slancio ravvicinato.
Uno scatto realistico accentuato dal nero
acceso dello scoglio, del ragazzo stesso e dell’amico che galleggia nell’acqua.
Sulla destra, invece, un’enorme nave naufragata, disastrata e abbandonata nello
sfondo di una luce grigia nebbiosa, che dà un senso indefinito, onirico di
sospensione del tempo, quasi metafisico.
Ecco che si incontrano da una parte l’atto
presente, realistico anche
cromaticamente, del tuffo; dall’altra in contrasto l’immobilità di un tempo
sempre uguale a se stesso e senza orizzonte.
Da qui si potrebbe filosofeggiare. Questo
contrasto rafforza la foto, perché dà al tempo che scorre “l’essere vivo” nel
tuffo, ma nello stesso tempo nel suo sfondo la “sua morte”. E viceversa. Che è
il destino di ogni foto: rappresentare l’attimo, che subito muore.
Fernando Herráez. Castelo do Queijo, ueQQuePorto. 1978.
04 settembre 2019
"Una giacca bianca" di Nicolò Pintacuda
Schegge d'erotismo per un discorso d'amore
di Luciano Luciani
Una giacca bianca, silloge poetica di Nicolò Pintacuda, al di là dell' apparenza slegata, frammentaria, potremmo definirlo un singolo, organico poemetto. È, infatti, composto di 95 brevi, brevissime strofe, alcune di appena tre versi, altre che arrivano sino a 12, massimo 14, quasi tutte senza titolo. Un' unica effusione poetica, spezzata, franta, singhiozzante in concisi, ridotti, intensi madrigali.
A parte due testi, Danae e Saffo, in cui il tono si eleva alla ricerca di modalità proprie della poesia classica, dove i testi di Catullo e i frammenti della poetessa di Lesbo fungono da modelli e da ispirazione, il linguaggio è apparentemente consueto, quotidiano, ordinario. Ma non inganni una tale operazione lessicale perché qua e là compaiono termini preziosi, desueti, disusati: pervio; sturma; magato nel senso di ammaliato; silerchie; piroforo; stigma; pneuma...
E poi, qua e là, disseminati nei versi. iperboli, sinestesie, allitterazioni, echi danteschi, echi biblici, procedimenti ossimorici. Sono, quelli di Pintacuda. i frammenti di un discorso amoroso, squarci improvvisi di una dimensione intima, segreta, nascosta in cui domina un eros intenso, ricorrente, permanente, profuso a piene mani. Un lui e una lei: lei sensuale, provocante, carnale, voluttuosa; lui, il suo servus currens, ammaliato e narrante una donna tanto più indispensabile e preziosa quanto più irraggiungibile, inaccessibile e lontana. Talora assente. E l'Autore ne soffre, nella psiche e nella carne, sino a esiti di cupa solitudine e disperata desolazione. Ecco cosa racconta, con discreta eleganza e un innato senso della misura, Una giacca bianca, dal verso eponimo che dà il titolo all'intera raccolta: una storia d’amore intrisa di piacere e di sesso, anche audace, che si fanno legame profondo, complicità condivisa, amicizia, reciproco completamento. La parola più frequente che la individua, variamente coniugata, è labbra: la parte del corpo destinata sia al bacio, sia alla parola. E l'uno e l'altra legano, uniscono, congiungono, comunicano...
Sanno di eccitamento dei sensi, di euforia dei sentimenti e di frustrazione, queste brevi strofe elaborate da un docente universitario di matematica che ha abbandonato gli algoritmi e le teorie della probabilità per la parola poetica. Un’operazione riuscita che incide e lascia tracce profonde nella coscienza del Lettore. Esaltazione e profonda delusione esistenziale, a cui solo la memoria delle gioie godute sembra in grado di proporre un barlume di redenzione esistenziale.
Nicolò Pintacuda, Una giacca bianca, Collana Vianesca/Poesia e narrativa, Marco Del Bucchia editore, 2019, Massarosa, pp.56, Euro 10,00
Iscriviti a:
Commenti (Atom)