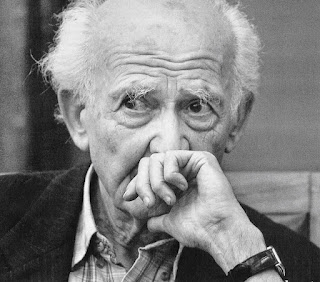Ho
ascoltato
Bauman a Pistoia, una straordinaria mente di quasi 90 anni,
pacata, lucidissima, realista, consapevole. Ho amato molto leggerlo
negli ultimi anni, utile spunto per poter comprendere quanto ci stia
accadendo attorno. Certo l’occasione dell’ascolto, della visione della
gestualità, della possibilità di godere dell’immagine, rende
l’esperienza intellettuale di gran lunga superiore rispetto a una
lettura. Tuttavia mi è mancato uno scambio, un domandare e un suggerire
punti di vista e questa mia sensazione di limite della docenza è stata
intensificata dal messaggio sostanziale del seminario. Mi spingo a
immaginare che lo stesso Bauman ne abbia sofferto, mentre visualizzo con
un sorriso la sua faccia e la sua gestualità all’ingresso in sala:
perplesso più che imbarazzato, è stato accolto da uno scrosciante
applauso preventivo, degno solo di una grande star hollywoodiana.
Obiettivamente rendere fruibile un intellettuale a un così vasto numero
di persone impedisce l’instaurarsi di relazioni di scambio, idealizzate
ma irrealizzabili perfino dal sociologo che le auspica come via di
uscita da un sistema in liquefazione. Ai miei occhi si è “salvato” con
quei suoi gesti di imbarazzo, quasi di fastidio di fronte
all’acclamazione, espressioni così umane, di uomo tra gli uomini, come
forse solo un umanista può rimanere anche mentre viene accolto come un
mito da degni rappresentanti di una società bisognosa di leader.
Non
posso trattenermi quindi dal rimettere in circolo con gli amici le
illuminazioni di cui sono stata ”vittima”. Uso il termine a proposito
non solo per ribadire la grande difficoltà ad venire fuori dalle
dinamiche relazionali soggetto-oggetto, ma anche e soprattutto per
rendere la sensazione di apertura che ho vissuto, di compenetrazione,
come se avessi subito una ferita che anche quando si rimarginerà non
lascerà niente come prima, e nessun legame resta nel tempo tanto stretto
ed è tanto trasformante quanto quello tra una vittima e il suo
carnefice. Appena uscita ho avuto bisogno di fermarmi al sole, poi con
calma mangiare qualcosa, poi rintanarmi a casa per dormirci su, solo in
seguito ho saputo ri-emergere dal vortice che mi ha creato,
metabolizzare l’incontro. Una sorta di sindrome di Stendhal, un orgasmo
intellettuale, che forse nasconde anche caratteristiche di violenza ma
non coercitiva. Mi appare necessario ripercorrere e condividere
quest’esperienza perché sia un gradino del cammino su cui cerco di
procedere, insieme a molti altri e credo che mai come adesso sia
necessario fare un passo insieme, proprio in questo momento storico in
cui sembra che uno solo dei passi possibili sia quello che ci porterà
“avanti” .
Bauman si è interrogato su una fotografia molto attuale della nostra realtà sociale.
Sono
stati molti recentemente su scala mondiale i “movimenti di piazza” come
quello spagnolo di Los Indignatos, le occupazioni di luoghi pubblici
più o meno significativi quali Wall Street, Piazza Tahrir, o i terremoti
politici più o meno annunciati come in Francia, nel Nord Reno
Westfalia, nelle ultime amministrative in Italia. È difficile dire che
cosa cerchino questi “movimenti”, più facile è ipotizzare che cosa
tentino di fuggire: solitudine, abbandono, vedere intorno persone tese
alla competizione, individualismo… Cosa riescono ad ottenere? Senz’altro
la liberazione assicurata da un’esperienza di piazza: l’incontro con
l’altro al di fuori delle ormai normali regole, delle contrapposizioni
pseudo-tribali, il ritrovarsi vicini, condividere sensazioni, emozioni.
Quelli che scendono in piazza cercano di stare uniti e ci riescono.
Vediamo persone unite, o almeno sembrano.
Gli occupanti
di Wall Street si dichiaravano il 99% della nazione, una nazione quella
americana, tra l’altro estremamente divisa, dal punto di vista etnico,
religioso, politico… “Noi siamo tutti contro l’1%” questo era il
messaggio americano, lo stesso certamente quello di Parigi, di Madrid,
della Grecia, ma anche delle italianissime 5 stelle, troppo poco
luminose per essere citate da Bauman - le cito io. La totalità
dichiarata da questo messaggio è una totalità immaginata, che permette
di ideare una nazione, la nazione desiderata, più piacevole di quella
reale.
Ma quali saranno le conseguenze di lungo periodo di questi movimenti
a cui istintivamente ognuno di noi vorrebbe partecipare?
Se
non resisteranno nel lungo periodo, la migliore conseguenza sarà
soltanto la forza liberante di un carnevale, durante il quale si
sovvertono le regole abbastanza a lungo per recuperare le forze
necessarie a ritornare nel quadro di una faticosa realtà. Certo ci sono
stati evidenti successi, purché “tragici”, conquistati da questi
movimenti, come ad esempio riuscire a togliere di mezzo chi non si
voleva più, un Mubarack, un Gheddafi, ma col tempo si presenta il
problema dell’individuare con chi soppiantare queste figure un tempo
carismatiche. Un altro immediato successo, anche più positivo, è dato
dall’opportunità di aver unito categorie sociali tanto diverse tra loro:
i poveri, gli affamati hanno manifestato al fianco del ceto medio che
pur non gridando la propria fame intendeva conquistare un potere
politico almeno pari al proprio potere economico. Tutti hanno sospeso
per un periodo le proprie diversità focalizzando e sostenendo insieme un
unico punto di accordo. Era accaduto anche con Solidarnosc e allora
rappresentava qualcosa di nuovo rispetto ai precedenti grandi scioperi
di categoria: tutti uniti si sovverte un regime, si elimina il problema
individuato, però quando successivamente si è trattato di discutere con
che cosa andasse sostituito, allora non è stato più possibile
raggiungere l’accordo.
Oltre il ricordo, di una lotta
unita e condivisa contro lo stesso obiettivo per una identica causa,
cosa resta? Nella nostra società una battaglia combattuta insieme può
ancora assumere i contorni di un’esperienza fondativa? Riesce a creare
una società più condivisa? Potrebbe farlo se riuscisse ad andare
definitivamente oltre la divisione, superando concretamente, nella
costituzione della nuova società, quell’esperienza di solitudine e
abbandono che ha attivato le occupazioni, i movimenti. Sarebbe possibile
concretizzando la solidarietà, come è accaduto in alcune epoche, ad
esempio in Italia con l’esperienza della Costituente.
Occorre delineare bene allora cosa significhi SOLIDARIETA’,
che è un concetto diverso da TOLLERANZA.
Tollerare
significa viversi accanto senza farsi la guerra, manifestarsi rispetto
lasciandosi in pace senza interferire. Tollerarsi può tuttavia celare un
pericolo: “Ti sopporto, ma io sono superiore, il tuo stile di vita va
bene per te, ma io non lo posso nemmeno sfiorare”. Chi tollera si sente
superiore, ma ha deciso di non farlo pesare. La tolleranza è quindi
strumento di riaffermazione di posizioni ed è destinata a condurre ad
una società diseguale. Certo la tolleranza rappresenta un passo avanti
formidabile rispetto a certe attitudini più arretrate. Nel nostro
secolo, forse come mai prima d’ora, siamo stati e siamo di fronte
quotidianamente al diverso, all’estraneo, allo straniero, allo strano.
Claude Lévi-Strauss, antropologo francese, ha teorizzato che l’umanità
abbia da sempre attuato due fondamentali strategie per tollerare il
diverso: ANTROPOFAGIA e ANTROPOEMESI. La prima conduce a ingurgitare il
diverso, distruggerlo annientando la sua identità, lo si elimina
inglobandolo; la seconda strategia prevede invece di vomitarlo,
escluderlo, rifiutarlo, respingerlo. Di fronte a queste due strade la
tolleranza si pone allora come un passo avanti.
La solidarietà è qualcosa di diverso e di più evoluto.
Hannah
Arendt, una famosa pensatrice tedesca naturalizzata americana, ha amato
molto Lessing, illuminista tedesco che ha avuto il coraggio di
affermare allora, che la diversità è qualcosa che rimarrà nel tempo, che
non è superabile. Coraggioso affermarlo in pieno illuminismo quando le
teorie prevalenti fissavano che esiste un solo modo di essere umani che
alla fine prevarrà. Arendt lo trova straordinario anche perché Lessing
era felice di questo stato di “eternità della diversità”, compiaciuto
della differenza ritenendola il fondamento della creatività umana: solo
la molteplicità della verità può produrre creatività. Un concetto a cui
molti ancora oggi non sono giunti e che a me incuriosisce molto: diverso
come originale e per questo creativo, capace di arricchire, creare
progresso, evoluzione. L’ottimismo di Lessing scaturiva però
dall’immaginazione della solidarietà piuttosto che della tolleranza.
Tolleranza è un comportamento che riconferma le differenze, ribadisce la
diseguaglianza tra soggetto ed oggetto: il tollerante preserva la
propria soggettività e considera l’altro, oggetto della propria
tolleranza. Nella solidarietà tutti sono soggetti, tutti i solidali
hanno diritto all’azione ad intermittenza, si è alternativamente
soggetto ed oggetto, docente e discente.
Questa “scoperta”
mi ha messo in discussione. Ho sempre sbandierato la mia tolleranza e,
perfettamente inserita nella categoria, mi sono sentita spesso forte
nella mia “superiorità” rispetto a chi tollerante non appare. Ho
suggerito, talvolta forzato, atteggiamenti di tolleranza, provando a
convincere chi istintivamente non era sulla stessa posizione, chi non
era tollerante. Mi capita frequentemente di sopportare con una certa
compassione posizioni a me estranee e distanti, ma certamente non sono
disposta a farle entrare in me, nella mia vita. Sarà per questo che mi è
apparsa davvero rivoluzionaria la strategia dell’antropologo tedesco
Kurt Wolff che Bauman ha citato come esemplificativa del concetto di
solidarietà: ARRENDERSI E CATTURARE. Chiaramente è un atteggiamento
misurato sull’antropologo: se vuole portare via le spoglie di un popolo,
conoscerlo, comunicarlo occorre prima di tutto che si arrenda
all’esperienza dell’altro, entrandoci dentro fino a dimenticare per un
determinato tempo la propria identità, il proprio stile di vita. Questa è
Solidarietà: io che divento te per diventare un nuovo me e per
realizzare un nuovo noi. Potrebbe forse essere la solidarietà così
definita, la chiave con la quale i movimenti di questi mesi possano dar
luogo ad una nuova società, il gradino da salire per trasformare il
carnevale in realtà quotidiana.
Che probabilità ha oggi la solidarietà di procedere?
Cosa si può fare per evolvere?
Bauman
ritiene che da 30-40 anni viviamo in un contesto sociale che definisce
“liquido”. La nostra è una modernità diversa da quella precedente. Fino a
40 anni fa il concetto di modernità era fondato su cittadini
PRODUTTORI; consumare era un bisogno naturale non indotto, il produttore
aveva un ruolo nella società, oggi un ruolo è assunto dal consumatore.
La società dei produttori era una varietà sociale SOLIDA e, benché si
sia macchiata di molti crimini, grazie alla rete di produttori era una
FABBRICA DI SOLIDARIETA’. Le fabbriche del ‘900 non avevano bisogno di
piazza Tahrir: gli operai stavano insieme, sperimentavano solidarietà
grazie al ruolo occupato nella società; le loro condizioni quotidiane
rendevano la sensazione di “vivere nella stessa barca”, collaboravano,
condividevano interessi e lagnanze. Si dava luogo ai grandi scioperi per
rivendicare diritti condivisi, rendere pubblici bisogni di categoria. I
movimenti di massa di oggi non hanno niente a che vedere con quei
grandi scioperi: gli occupanti di Wall Street hanno chiesto il
contributo di Lech Walesa, ma Solidarnosc, non può essere di sostegno a
queste nuove tendenze frutto della modernità liquida. Il movimento di
Solidarnosc si colloca in mezzo, forse come il primo dei nuovi movimenti
di massa, condivisi da molteplici classi sociali, ma anche l’ultimo dei
grandi scioperi dei decenni precedenti perché inserito in un contesto
sociale di tradizionale modernità.
Quella società non esiste più.
Pertanto è inattuabile un passo evolutivo fondato sulla solidarietà.
La
nostra società è deregolamentata, atomizzata, individualizzata, sono
state smantellate le condizioni di dipendenza che tenevano insieme gli
individui produttori. Destrutturate, le fabbriche si sono trasformate in
laboratori naturali di sospetto e concorrenza, quello che ci si aspetta
dall’altro, ormai non più collega, è sempre qualcosa di spiacevole, di
dannoso. Siamo di fronte a FABBRICHE DI SOSPETTO.
C’è
stato un periodo, neanche troppo distante, in cui gli intellettuali
investivano sul proletariato credendo che fosse la categoria in grado di
cambiare il mondo migliorandolo. Quegli stessi intellettuali si
ponevano su un piano di inferiorità rispetto ai proletari, si pensavano
deboli, capaci solo di scrivere e pensare, mentre i proletari erano
forti, in grado di combattere uniti e solidali. Ma oggi quella tanto
potente categoria è stata indebolita ed ha ceduto il posto al
PRECARIATO, una nuova realtà sociale che vive sulle sabbie mobili,
nell’incertezza costante, che ha una sola certezza: l’incertezza.
Allora, così come attraverso i processi storici del XIX secolo,
l’AGRICOLTURA ha ceduto il posto alla FABBRICA, allo stesso modo oggi il
PROLETARIATO tradizionale si sta restringendo a favore dei PRECARI. Il
precariato poi si diffonde a tutte le tipologie di lavoro, per cui
chiunque vive nell’incertezza o dei prossimi ”tagli” di governo che
fanno tremare i dipendenti pubblici, o della prossima razionalizzazione
aziendale che fa tremare i dipendenti del settore privato, o della
possibile esternalizzazione che blocca l’indotto… Tutti possiamo essere
vittime, non c’è niente da fare per rendere la propria posizione più
stabile; ad esempio alla Silicon Valley, massima ambizione sul piano
professionale per molti grandi cervelli, un buon contratto che si possa
strappare ha durata media di 8 mesi. A causa di questa precarietà non è
più possibile promuovere solidarietà, se non durante una passeggiata di
piazza, durante un carnevale, che prima o dopo finisce.
Un
tempo il proletario deteneva un potere: il valore del suo lavoro, da
cui l’efficacia dell’impresa dipendeva. Il rapporto di dipendenza che
legava il datore di lavoro al lavoratore era allora vicendevole. Oggi è
sbilanciato a causa della mobilità di entrambi in precedenza mai
sperimentata, dell’outsourcing, della sostituibilità. Qualche decennio
fa l’imprenditore era saldamente radicato al proprio territorio, la sua
fabbrica era possibile solo in quel luogo e lui stesso era lì che
intendeva rimanere, stava fisicamente al fianco dei suoi operai. La
realtà della mobilità odierna favorisce le distinzioni, le
diseguaglianze: prima, essere in qualche modo costretti a ritrovarsi
quotidianamente, dover addivenire ad un modus vivendi, sopportare una
quotidianità insieme, sul un piano umano, univa. Oggi la
contrapposizione tra soggetto ed oggetto è sempre più marcata e
pericolosamente non si autolimita: qualcuno può essere sempre più
libero, anche di dare comandi telematici comodamente seduto su una
spiaggia, qualcun altro perde perfino la libertà di combattere per i
propri diritti, di combattere per la propria libertà.
In
questo contesto liquido e disparitario solo l’individualismo sembra
garantire una personale certezza, una forma di solidità: solo
utilizzando l’altro a riempire le sabbie mobili sembra possibile venire a
galla, quindi è attraverso la competizione che si emerge, ma in modo
individuale, senza resa, senza i presupposti della Solidarietà.
Ad
amplificare tutto questo e ad impedire quindi ulteriormente la
possibilità di servirsi della Solidarietà come passo avanti per
l’evoluzione della società, ci si mettono gli incessanti flussi
migratori. La migrazione, da sempre costitutiva della nostra realtà è
destinata nel tempo solo ad aumentare. I lavoratori si spostano, con
tutte le migliori intenzioni, ma certamente non rinunciano volentieri
alla propria identità, così come chi li ospita. Quindi, condannati a
convivere col diverso, occorre trovare una strategia collaborativa
alternativa alla Solidarietà.
E qui Bauman si ferma.
Smette
di dipingere con estrema semplicità e lucida chiarezza un quadro dalle
tinte per niente rassicuranti, un triste paesaggio ormai allagato su cui
continua a cadere pioggia e che tutti noi negli anni abbiamo solo
innaffiato. Da attenta e silenziosa la sala si è fatta cupa e
mugugnante, reazioni istintive e distribuite sono state quelle di
sillabare qualcosa al vicino di sedia, di cercarne gli occhi, di leggere
un’espressione simile alla propria a rappresentare un conforto.
Velocemente e pacatamente era in atto un tentativo estremamente umano
di allontanare, per quanto possibile nell’Hic et Nunc,
quell’individualismo che abbiamo riconosciuto come concreta e
inesorabile parte delle nostre vite e che a tutti fa davvero paura. A
questo punto un uomo del suo calibro, con la sua storia, la sua
formazione, la sua esperienza, la sua intuizione, avrebbe facilmente
estratto il coniglio dal cilindro, ci avrebbe certamente sollevato,
meravigliato, in fondo quello che ci sia aspettava a quel punto era una
chiave concreta per aprire la via d’uscita. Bauman ha offerto un
materiale, tra l’altro neanche suo, e l’ha lanciato in sala come se
potesse essere la chiave di tutti quelli che riescano a raccoglierlo, a
forgiarlo, a limarlo perché lo strumento prodotto possa entrare nella
propria serratura.
Il sociologo
Richard Sennett si è
chiesto cosa significhi oggi, nel nostro tempo, essere umanisti ed ha
risposto introducendo la strategia approssimativa della “INFORMAL
OPEN-ENDED COOPERATION”. È un’ipotesi di certo estremamente libera ed
approssimativa, non è una mappa che ci indichi una strada, ha un limite
enorme, non insegna, suggerisce e in questo stesso limite sta la sua
grandezza: potrebbe essere il vento su cui possa galleggiare la società
liquida.
- INFORMALE: senza regole, senza norme, senza attese, neanche di risultato; le uniche regole possono emergere dal dialogo.
- APERTA:
cioè attuata a porte aperte dove chiunque possa entrare, ma anche a
mente aperta dove ognuno possa essere alternativamente docente e
discepolo, possa arricchire l’altro per quanto sia estraneo, alieno,
strano.
- COOPERAZIONE: non si tratta semplicemente di dialogo, di
discussione, di dibattito, non è un seminario universitario, nemmeno
un’arena dove alla fine predomina una posizione, dove uno avrà ragione
ancora prima di discutere. È qualcosa di più: è un impegno vicendevole
senza vincitori né vinti che si concretizza in operatività. Nessuno
potrà uscire vincitore, tutti saranno sempre più ricchi.
Non
si tratta di Solidarietà: in una società liquida dove non c’è sicurezza
non ci si può permettere il lusso di arrendersi e catturare. Il più
grande sforzo possibile è quello di aprire una porta in se’ stessi per
discutere su un piano paritario con l’altro, senza regole, come capita,
mettendo in gioco ogni parte di se’, con la consapevolezza che non
esiste una sola verità e che nessuno dei dialoganti sa dove si andrà a
finire. È uno sforzo superare il dialogo aperto e informale e renderlo
anche operativo, utilizzando energie fisiche oltre a quelle
intellettuali.
È per questo che ho dedicato un po’ del mio
tempo per scrivere: per non essere solo vinta dalla potenza del
pensiero di Bauman, per farmi attivo vincitore e trasformare la sua idea
con un pezzo di me, metterla in circolo perché chiunque possa
aggiungere nuovi mattoni ed edificare insieme una nuova società. Perché
in molti si possa cooperare, anche solo soffiando un buon vento su
questa troppa acqua. Allora ho provato a ripercorrere il filo del suo
ragionamento così come l’ho masticato, filtrato e sviluppato, senza
distinguere troppo il suo pensiero dal mio. L’eccellenza della
riflessione di Bauman mi porta a credere che non rivendicherebbe alcuna
paternità, che forse sarebbe lieto di una cooperazione informale e
aperta, che ritiene essere l’unico possibile nostro futuro. Di certo
troverebbe da correggere alcune mie semplicistiche e forse errate
interpretazioni, ma non sono altro che una mente alla ricerca, curiosa
ed “errante”.
da
il giardino degli elefanti