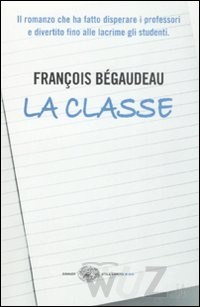di Davide Pugnana
“Scrivo ancora versi, non ne ho perso il gusto.
La passione
di scavare lungamente in una breve linea di
scrittura -
colosso dall’apparenza molto tenue - rivela uno
sregolato
attaccamento a tutto (conoscenza, amore, vita,
mondo, Dio)
ma il risultato non è buono se non si misura
subito, nel verso
compiuto. Forse c’è là, nel groviglio delle
vite, qualcuno che
aspetta di ricevere i nostri versi per
mangiarne la luce e fortificarsi,
indebolendo la morte, allontanando per un
attimo la paura?
Mi succede sovente si pensare che sia così.”
(Guido Ceronetti, Poesia
chiara poesia oscura)
I discorsi scritti dai poeti
in occasione del conferimento del Premio Nobel racchiudono folgoranti bilanci
di poetica. E nonostante questa meditazione sull’arte racchiuda quasi tutto il
senso di una vita ciò non è ancora abbastanza. Su quella decina di pagine,
vergate in una bellissima luce dilatata tra vissuto e presente, così
lucidissima e postuma nel piovere sugli oggetti interni, così impastata nella
memoria di lontananze siderali e di struggente disincanto, proprio in quel giro
di otto, novecento parole si fissa, una volta per sempre, l’idea totale che
della letteratura, della sua natura e della sua ragion d’essere, un artista ha
inseguito ed elaborato lungo tutta una vita, spesso a prezzi altissimi. In
testi di questo tipo non si tratta di stilare un consuntivo di poetica o una
definitiva planimetria delle proprie pubblicazioni. C’è in essi un tale
spessore evocativo, unito ad una potente luce d’intelligenza e ad una visiona
postuma di sé, che li avvicina al valore di un testamento spirituale. Davanti a
questa confessione preziosa, che l’ufficialità dell’evento e della lettura in
pubblico trasformano in “documento”, si ha quasi l’impressione che il premio
Nobel per la letteratura - e Brodskij lo dirà apertamente - sia una sorta di
invenzione, di passepartout creato a bella posta da coloro che, tagliati fuori
dai segreti della creazione artistica, desiderano carpire strenuamente il fondo
oscuro dell’arte, come instancabili segugi. Allora quale esca migliore per
catturare i segreti più intimi di un poeta che tendergli un premio capace di
innalzarlo allo statuto di “classico” in vita?
Iosif Brodskij si trovò a
tracciare queste pagine nell’autunno del 1987. Scrisse tre discorsi memorabili
e definitivi, raccolti in uno smilzo ma
densissimo volume. Dall’esilio (Adelphi, 1988, pp. 68, euro 7,65) è il
titolo che funziona come una cerniera che tiene unito il trittico formato da
una pala centrale e da due ante laterali. “Un volto non comune” è il
discorso per il premio Nobel. Partiremo da qui per avvicinarci al cuore
pulsante di questo poeta russo dall’esistenza difficile. Brodskij fu anche uomo
oltre che poeta. Non è un paradosso. Egli non ricevette in sorte un’agiata
esistenza borghese. Nelle pieghe dei suoi versi di marmorea bellezza classica
sono passati i mestieri più disparati: il fresatore in una fabbrica di
Leningrado; l’addetto alle caldaie in un bagno pubblico; l’assistente in un
anfiteatro di anatomia; l’operaio avventizio per una missione di geologi in
Siberia; e tra queste navigazioni possiamo inserire anche il nomadismo, a piedi
tra Russia e Asia Centrale o arrampicandosi sui ghiacciai del Pamir senza
provviste e senza attrezzatura alpinistica. In tanto dinamismo Brodskij riuscì
a trovare il tempo di istruirsi, imparando numerosissime lingue e giungendo a
conoscere alla perfezione l’inglese e il polacco; e ad impegnarsi nella
militanza politica, aderendo al realismo socialista del suo tempo. L’uomo
esplorò la sua condizione fino in fondo: lavorò, studiò, militò, coltivò gli
ideali buoni della sua generazione, e fece in tempo a farsi arrestare con l’accusa
di “parassitismo”, quindi ad essere spedito in un ospedale psichiatrico e poi
al confino in una lontana regione del Nord, per scontare cinque anni di lavori
forzati. Nella sua vita Brodskij provò quell’esperienza della persecuzione tout
court che lo rese un autentico personaggio kafkiano. Occorrerà aspettare il
1989 per vederne la “riabilitazione”. Questo è l’uomo che miracolosamente è
riuscito a sopravvivere. Il poeta continuò ininterrottamente il suo lavoro di
scavo dentro grandi temi metafisici ed esistenziali. Ed è singolare che di
tanta variata e inaudita materia biografica non ritroviamo che un pulviscolo
di vicende sparse in versi di classica
perfezione. Al Brodskij poeta interessava la tenuta e la purezza della
difficile e calibrata arte della versificazione. Egli sapeva bene che il testo
poetico sarebbe stata la vera forma con la quale la Storia l’avrebbe ricordato.
Se la vita quotidiana trasvolava tra bordi sfrangiati e precipizi spalancati
sull’assurdo, all’opposto la ’vita in versi’ andava costruendo un abito di
bronzo imperituro, inciso di assimilazioni classiche; di dialogo con la
tradizione; di recupero di un senso arcaicizzante, lavorando a innovare
strutture metriche come odi, ballate, elegie; e di segreto nutrimento nella
pratica di lettura e traduzione di poeti metafisici inglesi del XVII secolo,
quei John Donne e Andrew Marwell dai quali Brodskij imparerà a
trasformare il suo pensiero in materia da poemi. Non stupisce che proprio la
fama di Brodskij abbia ricevuto il sacro battesimo di W.H. Auden, all’epoca
vero e proprio classico vivente della letteratura inglese.
“Per una persona dedita alla
vita privata, per uno che ha sempre preferito la sua dimensione privata a
qualsiasi ruolo pubblico e che nell’esercizio di questa preferenza si è spinto
piuttosto lontano - lontano dalla sua madrepatria, per non dire altro, giacché è
meglio essere l’ultimo dei falliti in una democrazia che un martire o la crème
de la crème in una tirannia - per un individuo simile trovarsi all’improvviso
su questa tribuna è un’esperienza un poco imbarazzante e non poco impegnativa.”.
Con questo disarmante pudore esordisce Brodskij, davanti a quel premio che gli
chiede la confessione più difficile della sua vita. Il suo primo pensiero è
verso “coloro cui questo onore non è toccato, cui non è data la possibilità di
parlare urbi et orbi, come si
dice, da questa tribuna.” E chi sono questi spiriti magni tagliati fuori dalla
tribuna del Nobel? Sono i grandi poeti contemporanei morti da tempo, i nomi dei
quali Brodskij scandisce con commosso tenore dantesco: “Osip Mandel’stam,
Marina Cvetaeva, Robert Frost, Anna Achmatova o Wystan
Auden”: ombre che lo circondano con la loro grandezza e lo turbano perché “essere
migliore di loro sulla pagina non è possibile infatti; né è possibile essere
meglio di loro nella vita reale.[…] se l’altro mondo esiste, spero che essi mi
perdoneranno, me e la qualità di quello che sto per dire: in fin dei conti, non
è dal modo di comportarsi su un podio che si misura la dignità della nostra
professione.” Con queste parole d’esordio, Brodskij ci ha lasciata la più alta
prova di (auto-)coscienza letteraria, di confessione dei propri debiti
artistici, e, soprattutto, il raro esempio di un elogio del valore artistico
dei propri contemporanei. Tre livelli la cui statura e qualità etica valgono
bene un premio Nobel. Quali sono le osservazioni messe in campo da Brodskij?
Quali sono le idee che ha maturato sulla “natura” del mestiere di scrivere?
Come si fa a squadernarle glissando il pericolo di ridurle a “sistema”?
La prima funzione dell’arte è
quella di insegnarci qualcosa sulla “dimensione privata della condizione umana”.
L’impulso primario alla creazione artistica nasce dall’atto di un “Io
individuale” che il poeta non desidera condividere con la società, e anzi
sottrae allo sguardo dell’altro; ma che, almeno in un primo momento, intende
come ricerca sacra (ossia separata e nascosta) di una costruzione di orizzonti
di senso; come pulizia nell’interiore materia di “immondizia” (il sostantivo è
dell’Achmatova) che lo abita e che chiede un baricentro. “Un’opera d’arte, in
special modo un’opera letteraria e una poesia in particolare, si rivolge all’uomo
tete-à-tete, stabilendo con lui rapporti diretti, senza intermediari di
sorta.” Rientra nel quadro di questa riflessione sulla gestazione poetica l’origine
del titolo scelto da Brodskij per il suo discorso: il poeta Baratynskij attribuiva
alla propria Musa “un volto non comune” ed è questo il profilo sfuggente su cui
il poeta russo ha orientato il suo scavo al fondo dell’esistenza umana. Per noi
che viviamo nella privilegiata prospettiva storica dei posteri, il Novecento è
stato un secolo generoso di personalità altissime. Mentre nel Trecento, nel
Cinquecento e ancora nell’Ottocento, i poeti di genio si contavano a mala pena
sulla punta delle dita, di fronte alla sterminata fucina di poeti del XIX secolo
ogni tentativo di mappatura delle poetiche lascia fatalmente dietro di sé
odiose lacune e voci fuori dal coro. Brodskij, come Pasolini e Paul
Celan, è caduto dentro un secolo terribile, nel quale più volte la poesia è
stata messa in crisi e data per morta, come recitava lapidaria la sentenza di Adorno:
“scrivere una poesia dopo Auschwitz è barbaro e ciò avvelena anche la stessa
consapevolezza del perché è divenuto possibile scrivere poesie.” Malgrado il
pessimismo del filosofo, poeti come Brodskij, Mandel’stam, o Ungaretti
e Quasimodo da noi, non hanno mai perduto il senso di resistenza etica.
Nessuna concezione della poesia può essere messa sotto accusa: i grandi autori
non sono mai stati tanto poeti quanto in tempo di precarietà, di crollo dei
paradigmi umanistici e di perdita delle certezze storiche. Questo dato di fatto
è talmente ficcante da diventare il cuore geometrico del discorso di Brodskij: “Il
vero pericolo per uno scrittore non è tanto la possibilità (e non di rado la
realtà) di una persecuzione da parte dello Stato, quanto la possibilità di
farsi ipnotizzare dalla fisionomia dello Stato, una fisionomia che può essere
mostruosa o può cambiare verso il meglio ma è sempre provvisoria. La filosofia
dello Stato, la sua etica - per non dire la sua estetica - sono sempre ’ieri’.
La lingua e la letteratura sono sempre ‘oggi’ e spesso (specialmente nel caso
in cui un sistema politico sia ortodosso) possono addirittura costituire il ’domani’.
Nessun poeta, messo davanti alla necropoli del “secolo breve”, si è piegato
alla tentazione di fregiarsi “del titolo onorifico di ’vittima della storia’;
la sua ricerca anzi si è sempre orientata verso la costituzione di un senso
capace di restaurare quegli strappi feroci che la mano della Storia aveva
lasciato sul corpo dell’uomo. La poesia del Novecento non ha mai giudicato gli
oppressori secondo criteri di semplice moralità: tenendosi in uno spazio
premorale ha cercato con lucidità di metterne a nudo le ragioni oscure di
violenza e di distruzione. Ne è un esempio l’intera produzione scritta di Primo
Levi. Dalle sue pagine Brodskij ce lo spiega così: “Possedendo una
genealogia propria, una sua dinamica, una sua logica, un suo futuro, l’arte non
è sinonimo di storia, ma nel migliore dei casi corre parallela alla storia; e
può esistere solo creando continuamente una nuova realtà estetica. Ecco perché
si scopre spesso che l’arte è ’in anticipo sul progresso’ - non dovremmo
correggere Marx una volta di più? - è esattamente un cliché.” Se apriamo
la raccolta di poesia di Trotskij e andiamo a leggere ciò che scriveva durante
gli anni delle persecuzioni e del processo del 1964 del quale fu ingiusta
vittima, troviamo versi innervati di una linfa vitale meravigliosa, come questo
squarcio notturno che ha la luce di una ronda di Rembrandt: “L’uomo riflette
sulla propria vita,/ come la notte sulla lampada. A un momento dato/ oltrepassa
i confini di uno dei due emisferi/ del cervello il pensiero, scivola come una
coltre, / denudando qualcosa, forse un gomito; la notte/ è ingombrante, questo è
vero,/ ma non così smisurata da pensare che ricopra/entrambi gli emisferi. E l’asia
e l’europa/ del cervello, e le altre gocce di terra in mare, e l’africa/ a poco
a poco scricchiolano sull’asse secca, ruotano,/ esibendo la loro vizza gota,/ verso l’airone elettrico.” (Ninnananna
di Cape Code). Perfino in quegli anni terribili, Brodskij fu capace di una
resistenza in versi di questa levatura: “Metti in serbo per le stagioni fredde/
queste parole, per le stagioni dell’ansia!/ Come il pesce sulla sabbia, l’uomo
sopravvive:/ se si strascina agli arbusti e s’alza/ su gambe incerte e storte
va, come un rigo di penna, / nelle viscere stesse della terra.// Esistono leoni
alati, sfingi col seno/ di donna, angeli in bianco e ninfe del mare:/ a colui
che sostiene sulle spalle il peso/ di buio, caldo e - oso dirlo - dolore, /
sono più cari gli zeri concentrici nati/ da parole gettate.” Il premio Nobel
vinto da Iosif Brodskij non è un trionfo individuale, ma collettivo, diremo di
una genia benedetta ed eroica. È il
Nobel guadagnato da tutta la generazione di poeti del XIX secolo, e dei poeti
russi in particolare, che egli ricordava ad apertura di discorso e che torna a
richiamare nella chiusa, tracciando le linee portanti di un’autobiografia umana
e intellettuale: “Questa generazione - la generazione nata proprio nel momento
in cui i forni crematori di Auschwitz lavoravano in pieno regime, in cui Stalin
era allo zenit del suo potere divino, così assoluto da sembrare avvallato da
Madre Natura in persona - questa generazione è venuta al mondo, si direbbe, per
continuare quello che, in teoria, doveva interrompersi in quei forni crematori
e nelle anonime fosse comuni dell’arcipelago staliniano. Il fatto che non tutto
si sia interrotto - almeno in Russia - è un merito che va attribuito in misura
non trascurabile alla mia generazione; e io sono fiero di appartenerle.”
A lato di questo abbagliante
pannello centrale troviamo La condizione che chiamiamo esilio, una
manciata di pagine nelle quali Brodskij deposita un ulteriore, e se vogliamo più
impalpabile, elemento della sua ricerca esistenziale condotta per via di
ostinato e severo scavo poetico. Questo anello è la permanente condizione di
esilio. Esilio non tanto fisico e biografico, storicamente determinato da un cambio
di geografia e da una perdita della terra d’origine. Esiste un sentimento
dell’esilio che difficilmente le parole possono raccontare, raggiungere e
sagomare in un senso rotondo. Spesso ne troviamo traccia nelle liriche di
Brodskij: “Mettiti in una nicchia vuota e, rovesciando/ gli occhi, guarda
svanire dietro l’angolo/ i secoli, e il muschio ricoprire il ventre/ e le
spalle la polvere, tinta del tempo.” (Torso); “Là, oltre il nulla, oltre
il confine estremo,/ - nero, incolore, ma chissà, forse bianco - / c’è
qualcosa, un oggetto./ Un corpo forse. Nell’èra dell’innesto a frizione/ la
luce viaggia alla velocità della visione,/ persino quando a noi risulta spenta.”
(Laguna). È l’esilio costitutivo dei temperamenti poetici, le cui
propaggini si perdono in una profondità interna e ontologica che la rendono
categoria metafisica e scenario malinconico. Dall’esilio è tuttavia un
titolo parlante e rivelatore: la scelta strategica di un complemento di luogo
in forza di uno di specificazione (Dell’esilio) evita la trattazione distaccata
di un tema per mettere letteralmente in moto una voce animata dal desiderio di
giungere a noi come portata da una folaga narrativa che, per quanto obliqua e
difficile, non si avverte impossibile. Che cosa ci porta la voce di Brodskij
dall’esilio? Un imperativo etico ed estetico, nel cui fuoco l’uomo e il poeta
diventano un’entità senza possibilità di fratture: parlare. È questo il verbo
magico che ricorre a definire questa sfuggente “condizione”, psichica e
metafisica, cui diamo il nome di “esilio.” Di questo “interno paese straniero”,
come lo definì Freud, parlano gli scritti in prosa di Iosif Brodskij.
Tra i tanti passaggi
sottolineati a matita in questa serata di fiaba e di neve nell’ultimo scorcio
di febbraio, vorrei trascriverne uno che si manifesta con la cifra di un exemplum
e di un attualissimo monito: “Eppure dobbiamo parlare; e non solo perché la
letteratura, come i poveri, è notoriamente portata a prendersi cura dei propri
figli, ma più ancora per via di un’antica e forse infondata convinzione,
secondo la quale se i padroni di questo mondo avessero letto un po’ di più,
sarebbero un po’ meno gravi il malgoverno e le sofferenze che spingono milioni
di persone a mettersi in viaggio. Poiché non sono molte le cose in cui riporre
le nostre speranze di un mondo migliore, poiché tutto il resto sembra
condannato a fallire in un modo o nell’altro, dobbiamo pur sempre ritenere che
la letteratura sia l’unica forma di assicurazione morale di cui una società può
disporre; che essa sia l’antidoto permanente alla legge della jungla; che essa
offra l’argomento migliore contro qualsiasi soluzione di massa che agisca sugli
uomini con la delicatezza di una ruspa […] Dobbiamo parlare perché dobbiamo
dire e ripetere che la letteratura è una maestra di finesse umana, la più
grande di tutte, sicuramente migliore di qualsiasi dottrina; dire e ripetere
che, ostacolando l’esistenza naturale della letteratura e l’attitudine della
gente a imparare le lezioni della letteratura, una società riduce il proprio
potenziale, rallenta il ritmo della propria evoluzione e in definitiva, forse,
mette in pericolo il suo stesso tessuto. Se questo significa che dobbiamo
parlare di noi, tanto meglio: non già per noi stessi, ma forse per la
letteratura.”
Iosif Brodskij, Dall’esilio,
Adelphi, Milano 1988, pp. 68, euro 7,65