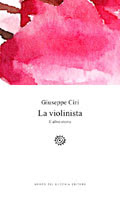di
Giancarlo Beriola Un
verme sta strisciando sul terreno di un prato, improvvisamente gli cade addosso
del terriccio e istantaneamente si arrotola su se stesso; una persona è distesa
al sole sulla sabbia con gli occhi chiusi, improvvisamente le cade addosso
della sabbia: apre subito gli occhi e si alza in piedi.
Entrambi hanno “percepito” qualcosa che
accadeva là fuori (fuori da sé) e “sentito” (dentro di sé) che accadeva loro
qualcosa e vi hanno risposto con uno stimolo motorio. “Quest’idea che
esistano due diverse modalità di rappresentazione degli stimoli, le sensazioni,
quello che accade a me, e le percezioni, quello che accade là fuori, è
un’idea di Humphrey [Nicholas, psicologo evoluzionista] che prende a
prestito da Thomas Reid (1710-1796) filosofo della Scuola scozzese”.
La citazione è tratta
dall’interessantissimo saggio di Giorgio Vallortigara Pensieri
della mosca con la testa
storta,
che cerca di dare una risposta ”... al
problema della coscienza animale. ... Qui per coscienza intendo il fatto
di avere esperienze, di provare, di sentire qualcosa quando si sfiora una
guancia con le dita, si odora della menta o si guarda il fondo di una pentola
bruciacchiata ... E la confusione è causata dal mescolare liberamente il tema
dell’avere coscienza con quello del mostrare certi comportamenti. Non è ovvio
quando e perché alcuni comportamenti semplici o complessi siano accompagnati da
un sentire, dal fatto di avere esperienze”.
Come è possibile quindi che in situazioni
simili un verme e un homo sapiens abbiano le stesse reazioni? L’essere
coscienti potrebbe essere una risposta ma si dubita che i vermi siano coscienti
(possiederebbero troppi pochi neuroni...) in quanto si ritiene che solo cervelli
voluminosi permettano tale stato ma, se così fosse, quale sarebbe la dimensione
necesssaria? “Prendiamo il caso dei cetacei. La grande intelligenza di
questi animali viene spesso associata ai capienti volumi dei loro cervelli. In
realtà specie diverse mostrano dimensioni alquanto variabili - dall’etto e
mezzo scarso del delfino dell’Indo ai ragguardevoli sette chili della
megattera”. E, utilizzando il quoziente di encefalizzazione (massa del
cervello rapportata a quella che ci si aspetterebbe di trovare in un tipico
animale della stessa taglia), si scopre che nella specie Steno bredanensis
è pari a 4,95 mentre per i capodogli è di 0,16.
Anche il numero dei neuroni presenti in un
cervello non è un indice significativo di intelligenza (302 neuroni il verme,
86 miliardi l’uomo - come si sia arrivati a questo preciso numero lo trovate
nel libro stesso) in quanto “al variare delle dimensioni dei cervelli il
numero dei neuroni può cambiare in maniera diversa nelle differenti specie. Nei
primati i neuroni aumentano con lo stesso tasso con cui si accrescono i
cervelli ... Nei roditori, invece, la grandezza dei cervelli aumenta più di
quanto aumenti il numero dei neuroni” (per sintesi: in un grammo di
cervello di una scimmia di taglia piccola troviamo lo stesso numero di
neuroni che in un grammo di cervello di una scimmia di taglia
grande; invece potremmo trovare più neuroni in un grammo di cervello in
un roditore di taglia piccola rispetto a quello di un roditore più grande).
“Nel libro
svilupperò idee che sono antitetiche a questo modo di concepire il problema
dell’esperienza cosciente [grado zero di coscienza del verme e grado massimo
per l’uomo] ... In particolare sosterrò la tesi abbastanza estrema che le
forme basilari della vita mentale non necessitino di grandi cervelli e che il
surplus neurologico che si osserva in alcuni animali sia probabilmente al
servizio dei magazzini di memoria, non dei processi di pensiero o della
coscienza”.
Quindi, se non è la dimensione del cervello
che determina i processi di pensiero o della coscienza (molti gli argomenti nel
saggio che lo dimostrano...) qual è il substrato che ha permesso questi
processi? Secondo Vallortigara questi processi sono sollecitati dalla capacità
delle cellule di sentire, capacità, questa, derivante dall’acquisizione
del movimento volontario che ha reso necessario distinguere il dentro
dal fuori di sé.
“Quello che chiamiamo senziente è un
organismo che deve in primo luogo distinguere tra i segnali che genera egli
stesso e quelli che sono generati sulle sue membrane da tutto ciò che è altro
da lui. Per avere il genere di movimento attivo che renda possibile
<sentire> la stimolazione è necessario disporre di un distinto sistema
recettoriale che agisca su un distinto sistema motorio”.
Strutturati questi due sistemi -
recettoriale e motorio - qual è il meccanismo che permette la distinzione tra
un impulso interno e uno esterno?
Supponiamo che dal cervello arrivi un
segnale (o stimolo) ai muscoli extraoculari che fanno muovere gli occhi,
segnale che chiamiamo efferente; una copia di questo segnale
efferente viene inviata al comparatore che “attende” un segnale afferente
cioè un impulso che dall’esterno, attraverso gli organi di senso, arrivi al
sistema nervoso (nota: in questo caso il segnale afferente che si produce è il
risultato dello scorrimento dell’immagine sulla retina).
Il segnale afferente passerà anch’esso dal
comparatore ma, essendo presente la copia efferente che dimostra che lo stimolo
iniziale è stato prodotto internamente dal movimento degli occhi anziché dal
movimento di un oggetto esterno, il segnale afferente verrà cancellato.
In un caso opposto, invece, se un segnale
esterno (afferente) arrivase al comparatore questo, non avendo ricevuto
alcuna copia efferente, lo lasciarebbe passare perché arrivi ai neuroni
preposti.
Torniamo allora al nostro verme che riceve
sulla pelle il terriccio o alla persona che stesa al sole riceve sulla pelle la
sabbia: il segnale afferente trasmesso dalla pelle non verrà cancellato ma sarà
registrato come qualcosa di esterno e il sistema sensoriale manderà il segnale
dovuto (di reazione o di accettazione o di indifferenza...); questa azione
viene assimilata come esperienza.
“Come hanno notato molti autori, questa
che viene posta in essere dal meccanismo di copia efferente costituisce in
effetti una primitiva distinzione tra sé e non-sé, il passo cruciale per la comparsa
della coscienza (alias esperienza). Ma come può il meccanismo della copia
efferente produrre l’esperienza? L’esperienza, se seguiamo le intuizioni di
Reid e Humphrey, è associata alla sensazione, a quello che succede a noi, e si
manifesterebbe perciò proprio quando il segnale di copia efferente non è
presente, quando cioè il segnale sensoriale non viene annichilito dalla
scarica corollaria [o copia efferente]. Si noti, a questo riguardo, che
quasi tutti gli autori sembrano credere il contrario perché non distinguendo
tra sensazione e percezione, associano il ruolo dell’azione motoria alla
percezione”.
A questo punto credo si sia compreso quanto interessanti e complessi siano “i pensieri
della mosca” considerando che quanto scritto è solo un accenno rispetto al contenuto
del ricchissimo saggio di Vallortigara, scritto con una forma piana ed elegante
e mai noioso, che sollecita curiosità e interesse.
Ah, alla mosca Eristalis tenax, per
un esperimento, è stata ruotata la testa di 180 gradi (cosa che può fare
normalmente...) ma “testa storta” (anziché ritorta), dice l’autore, nel titolo
suona meglio.
E, a proposito di esperimenti, tra i vari
presentati nel saggio c’è ne uno nel quale una scimmia di nome Helen è stata
chirurgicamente resa cieca: a lei e a tutti gli animali sacrificati (non solo
in nome della scienza...) sento di fare le mie scuse.
Giorgio Vallortigara è professore
di Neurologia e Cognizione animale presso l’Università di Trento. In precedenza
Adelphi ha pubblicato Cervelli che contano (scritto insieme a Nicla
Panciera, 2014).
Giorgio Vallortigara. Pensieri
della mosca con la testa
storta
(Adelphi, 173 pagg., € 20,00)