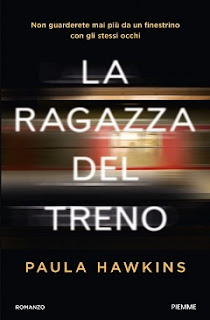|
| EMILE CIORAN |
Quelle
immagini della morte, ad esempio, che ho e abbiamo avuto negli occhi - morte di
un'epoca di divisioni politiche e morte di esseri umani - quanto, oggi,
condizionano, o hanno messo in crisi e modificato, la riflessione
sull'intreccio di paradigmi della modernità quali caducità/immaginazione/illusione?
Penso questo spronato da alcuni passaggi di un piccolo libro di Emile Cioran, "La fascinazione della cenere" che raccoglie scritti sparsi, pubblicati tra 1954 e 1991. Lo riapro e scorro titoli che avevo dimenticato; ma che mi permettono di ritrovare alcuni nuclei generatori di interessi, oggi, ancora molto vivi in me: "Intorno a Machiavelli", "Da Vaugelas a Heidegger", "Incontri con Paul Celan", "Nicolas de Stael o la vertigine", fino a "Contro l'immagine".
Tra questi c'è uno scritto su Leopardi. Sono poche pagine, di grande intensità autobiografica:
"Mi sono sentito, e mi sento
sempre, così vicino a lui nei miei stati di prostrazione, d'abbandono e
d'orrore [...] a causa ovviamente della noia, piaga della sua vita e
piaga della mia, con questa differenza tuttavia: che essa fu nel suo
caso generatrice di poesie immense e non soltanto di qualche frase
scucita. Ma, barbaro dei Carpazi, oso comunque paragonarmi al suo
'pastore errante' e non penso di essere stato indegno di lui quando,
nella mia giovinezza, colpito dalla vastità e universalità del non
senso, mi gettavo a terra tra sospiri e convulsioni, in preda ad uno
spasimo estremo, certamente meno elegante in questo del pastore
asiatico. "
A volte ho l'impressione
che quelle immagini della morte nella Storia - che hanno mescolato lo
sgretolamento architettonico alla lacerazione della pelle umana; la durezza
incrollabile del cemento e del metallo alla docilità della carne, ponendoli,
con un crudele livellamento, sullo stesso piano di 'cose' - abbiano agito,
nella mia generazione, come allegorie di fascinazione e repulsione della
"cenere"; come se esse avessero mandato in rovina non solo la dignità
dell'uomo e la stessa nozione di civiltà; ma una reale facoltà di speculazione
e una lotta per le illusioni che, oggi, sembra essere crollata o preclusa, o
assente, alla mia generazione.
Penso questo spronato da alcuni passaggi di un piccolo libro di Emile Cioran, "La fascinazione della cenere" che raccoglie scritti sparsi, pubblicati tra 1954 e 1991. Lo riapro e scorro titoli che avevo dimenticato; ma che mi permettono di ritrovare alcuni nuclei generatori di interessi, oggi, ancora molto vivi in me: "Intorno a Machiavelli", "Da Vaugelas a Heidegger", "Incontri con Paul Celan", "Nicolas de Stael o la vertigine", fino a "Contro l'immagine".
Tra questi c'è uno scritto su Leopardi. Sono poche pagine, di grande intensità autobiografica: