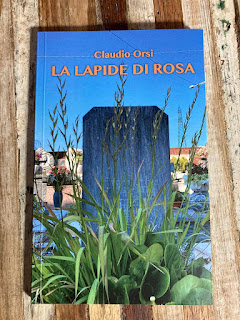di Elisa Bertoni
Un libro di racconti, forse
ancor più di un romanzo, è una grande sfida sia per lo scrittore sia per un
critico che voglia recensirlo. Lo scrittore deve riuscire in una sintesi
efficace a creare una storia che regga, che appassioni: sa che non può sforare,
a rischio di compromettere la riuscita del racconto. Non è un ingegnere di
grattacieli o di grandi palazzi, ma piuttosto un orafo o un miniaturista, che
nel microcosmo del suo gioiello e della sua pittura, deve riuscire a fare
emergere un'immagine perspicua e affascinante. Nello stesso tempo, ogni piccola
creazione viene accostata ad un'altra per dare vita ad un libro che ha un senso
nel frammento ma ne ha uno anche nella globalità.
Se il romanzo è uno, il libro
di racconti è nello stesso tempo uno e più, singolarità e pluralità. In questo
caso l'autore rende ancora più stimolante il dialogo tra singolarità e
pluralità perché i racconti sono inseriti in quattro sezioni, definite
arcipelaghi, rispettivamente intitolati Sangue, E' questo amore, Case
e Slittamenti. Dunque abbiamo il singolo racconto, la singola sezione e
l'intero libro: in questo dialogo si nasconde una potente attrazione anche per
un lettore critico, il quale è sollecitato ad analizzare le parti, ma per un
inevitabile orgasmo intellettuale, è spinto anche a voler trovare un senso
complessivo, quasi un filo conduttore, che potremmo anche definire, in questo
caso, il “filo di Arianna” che conduce fuori dal labirinto della complessità
dei significati, riconoscendo lo stesso mare nel variegato movimento delle
onde. Resta l'umile consapevolezza dell'irriducibilità di un libro ad un
discorso, nella certezza che quel filo conduttore individuato non è l'unico
possibile ma solo una lente attraverso cui leggere il multiforme.
E perché poi un racconto
diviene il titolo dell'intera raccolta? Solo perché è il primo? O forse perché
il mostro incarnato dal Minotauro può trovare ospitalità e parola nella
coerenza delle storie che volutamente incastonano la realtà con tutte le sue
voci come una pietra preziosa con le sue innumerevoli sfaccettature?
Autenticità significa raccontare partendo da dentro, senza censure dettate da
uno stereotipato linguaggio di convenienza. Il linguaggio originale, ricco e
nello stesso tempo quotidiano e naturale diviene il mezzo attraverso cui
esprimere il conflitto, la morte prematura, la rabbia edipica, la rivalità
amorosa, il fine vita, il tradimento, tutti aspetti che sbocciano da semi di
realtà, come li definisce l'autore, in cui il lettore può riconoscersi senza
bisogno di erigere barriere. Anzi, uno dei meriti più grandi del libro è lo
sprone a spogliarsi, ad accettare di sentirsi più nudi, vale a dire più vicini
al proprio nucleo di verità, puntando la luce negli angoli di sé ritenuti più sporchi,
più simili alla solitudine del Minotauro, drammaticamente “solo anche tra le
braccia della madre”, come si legge nel testo. Perché prima o poi tutti
avvertono una sensazione di sradicamento, di bisogno di ancoraggio ed allora,
nella solitudine più profonda e spaesante, esistono comunque i racconti, da
scrivere per ascoltare sé nello scorrere fluente della pagina e da leggere per
sintonizzarsi con le voci degli altri. La scrittura prodotta e fruita diviene
la grande madre cui appigliarsi, che non tradisce né abbandona. Afferma la
giovane protagonista del racconto Tempo al tempo, alle prese con il “monstrum”
cioè, secondo il termine latino, l'eccezionalità spaventosa di aver perduto
troppo precocemente la madre : “E' con mia madre che ho imparato a giocare
con le parole, a trovare un nido dentro le parole e a riconoscerne la forza
risanatrice...Quella forza che non abbiamo trovato in nessun'altra
medicina”. Dunque il libro è anche un monito a vincere con le parole e per le
parole per le quali si avverte il profondo amore dello scrittore.
Monstrum, forza della
parola: a questi due concetti chiave se ne potrebbe aggiungere un terzo, il
rovesciamento. Un potente filo conduttore è infatti ravvisabile nel tentativo
di rovesciare i luoghi comuni, talvolta abbracciandosi al paradosso o al
visionario che acquista il sapore di una magia attendibile. Perché il libro,
anche quando pare creare situazioni al limite del verosimile, attinge con forza
al banchetto della verità, tenendo conto che anche l'irrazionalità di certe
esperienze allucinatorie si nutre della realtà dei nostri stati che in certi
momenti sono fatti più di fantasmi che di concretezza. Accogliere e far parlare
il monstrum, qualsiasi esso sia, è proprio un rovesciamento rispetto
all'abitudine di volerlo nascondere negli oscuri e labirintici recessi della
nostra psiche; senza contare che un monstrum intrappolato dentro rischia
proprio di nutrirsi delle forze più vitali in nostro possesso, incarnate nel
mito dalle carni giovani di cui annualmente si nutre il Minotauro.
Questo bisogno di
rovesciamento si riscontra appunto fin dal primo racconto inserito nella
sezione “Sangue”. “Da secoli lascio che la gente mi tema, senza
sospettare che sono io a temere il peggio”. Così parla il mostro umano dalla
faccia taurina frutto dell'indicibile amplesso della madre Pasifae, moglie di
Minosse re di Creta, con un toro; il mostro pervaso dalla brutalità della
bestia selvaggia che deve essere separato dal resto dell'umanità; il mostro che
divorava ogni anno sette fanciulli e sette fanciulle ateniesi, divenendo
simbolo di ferocia disumana.
Eppure, bisognerebbe avere
il coraggio di amare quel mostro alla luce del sole, senza essere vittime del
dissidio interiore da cui è lacerata Pasifae che, pur avendo desiderato questo
suo ibrido figlio, lo nasconde, forse inconsapevole che esso rappresenta
davvero qualcosa di speciale, perché, come afferma il Minotauro stesso
“...dalla passione escono solo sorprese speciali, e io sono sceso nel mondo per
mano della passione”. L'uomo vuole oscurare tutti quei pensieri che si
scontrano con una forma socialmente costituita, fino a voler uccidere il
Minotauro, come fece l'eroe ateniese Teseo. Ma l'uomo contemporaneo, incarnato
dallo scrittore, non può più coltivare l'illusione di potersi disfare del
monstrum uccidendolo, neppure se aiutato dal filo di Arianna; il Teseo
contemporaneo ha invece il compito di liberare il Minotauro nutrendosi di esso
e tenendosi ad un altro filo, quello del racconto, che accoglie l'indicibile ma
gli impedisce comunque di superare il limite, lasciando che si esprima ma
sempre entro le ordinate regole di un linguaggio che vuole comunicare
autenticità, sottraendo la scrittura al rischio di scadere in retorica. Ecco
l'originale rilettura rovesciata del mito: non sarà più il Minotauro a mangiare
i giovani ma i giovani a mangiare il Minotauro, quasi un mitico Cristo che si
immola perché la vita possa essere intera, non privata di quegli aspetti di
vero che turbano e che parrebbero confliggere con il perbenismo socialmente premiato.
Da questo punto di vista non
devono stupire esternazioni che potrebbero turbare, ma che sono “mostri di
realtà” originati dalla passione e per questo mai gratuiti e fini a se stessi.
Si leggano da La luce è
spenta le lucide parole di un figlio di fronte alla malattia incurabile che
ha colpito il padre: “I malati possono essere profondamente noiosi come i sani,
e mandarli a quel paese, mandarli da qualche parte finché sono in vita, è un
sacrosanto diritto: e andate a fare in culo, perlomeno andateci prima di
morire!”. Chi conosce autenticamente la malattia sa come essa sia capace di
trasformare non solo il corpo ma anche la mente del malato, rendendo le
relazioni sempre più tese ed affannose, nel groviglio di sentimenti fatti di
paura, dolore, orgoglio ferito, senso di inadeguatezza e di precipitosa
perdita: raccontare la malattia nella sua realtà significa perciò salvarla
almeno dall'apparenza di una facile carità dovuta di fronte all'essere umano
che soffre e che meriterebbe tutta la dolcezza, la comprensione infinita che la
compassione umana e cristiana è capace di sprigionare. Il racconto insegna a
comprendere anche gli stati d'animo di chi del malato si prende cura, senza che
i sentimenti talora contraddittori possano essere giudicati, ma appunto liberati,
affrancandosi dal senso di colpa sempre in agguato, specie quando si tratta di
“onorare il padre e la madre”. A questo proposito risulta decisiva la rilettura
del Padre Nostro che ne fa il giovane protagonista del racconto Diciannove
anni: “Padre stronzo mio, che sei davanti a me, sia maledetto il tuo nome,
schianti il tuo potere e sia fatta la mia volontà, in terra, in cielo e
ovunque. Dammi oggi il tuo fiele quotidiano, rimetti a me la sfiga di esserti
figlio come io ributto addosso a te la mia rabbia, non m'indurre in parricidio
ma liberami dal male di averti davanti”.
Se questo passo,
decontestualizzato, potrebbe apparire di blasfema gravità, Daniele D'Arrigo riesce a
renderlo non solo giustificato ma necessario, facendoci partecipi dall'interno
del conflitto che si muove nel cuore del giovane, alla ricerca di una
realizzazione in amore che passa attraverso un taglio netto, oltre le
manipolazioni affettive che caratterizzano più o meno intensamente la
quotidianità delle relazioni familiari: a diciannove anni non sappiamo se
saremo in grado, spezzata la corda, di navigare da soli nel mare della vita.
Rovesciamento potente, dunque, del quarto comandamento.
Anche nel racconto
intitolato Il tuffo la voce che si esprime in prima persona è quella di
un ragazzo, anche lui capace di leggersi dentro al di là di idealizzazioni
programmatiche suggerite dalla convenienza sociale. Orfano di madre che non ha
mai conosciuto, guardando una foto di lei a Venezia, afferma con spontanea
genuinità: “...a me questa mamma non dice nulla. E' una perfetta sconosciuta”.
Parole di verità, non onora un fantasma vuoto, piuttosto, chiamato a
raccontarla, costruirà la “sua” mamma, attribuendo ad essa le caratteristiche
fisiche e caratteriali colte in figure femminili effettivamente conosciute. Al
fantasma imposto sostituisce il parto libero della propria autentica
immaginazione. Ed è proprio in questo racconto che il tema del rovesciamento
viene esplicitamente menzionato, in uno svelamento che diventa quasi violento
nel cuore di un ragazzo che per la prima volta sperimenta la cinica amarezza
della disillusione: “...Bufalone ha un cuore. Incredibile. Il mondo s'è
rovesciato e mi viene da ridere”. E questo mondo rovesciato, ripetuto poco
sotto nella pagina, non va accolto con paura, ma quasi con il sorriso che
esplode quando il disorientamento è talmente profondo che poco ci manca alla
follia.
E così, andando avanti nel
libro, troviamo tante situazioni che sfiorano il paradosso e che pure hanno il
sapore genuino di una pietanza condita di realtà.
Nel racconto Scegliere
casa il rovesciamento pare cogliersi quando la coppia protagonista
preferisce costruire “il fuori” che non c'è piuttosto che “il dentro”
dell'abitazione che l'agente immobiliare sarebbe lieto di mostrare. Sembra
quasi la metafora di un amore fragile che si costruisce nell'esterno in
un'apparenza volatile e non nel profondo, sulla realtà dei sentimenti. Anzi,
c'è un preciso evitamento che frena nel guardare dentro forse per paura di
scontrarsi con il fallimento della storia, che non ha possibilità di radicarsi
e continua a nutrirsi di reciproche fantasie.
Ed ancora strabiliante
paradosso quello che lega, attraverso un muro che costa come una casa, una
coppia capace di vivere insieme per quarantacinque anni, avvelenandosi
costantemente. Si chiede il narratore: “Cosa ci tiene attaccati a uno scoglio
frantumato? Questi due erano malati gravi e si erano ammalati conducendo
semplicemente una vita agiata e pessima. Accumulando cose e case, miserie e
dispetti...”. Una dipendenza patologica fa desiderare la costruzione di un muro
al prezzo di oltre duecentomila euro, che possa permettere di vivere
perfettamente separati ma nella stessa casa: “E' nella divisione che hanno
trovato e custodito la massima unione”, sentenzia il narratore, arreso
all'apparente assurdità di una realtà sperimentata.
Nel racconto E' tutto
normale, buon compleanno anche il titolo parla da solo. In cosa consiste
questa normalità dichiarata? Ciò che apparentemente potrebbe apparire non
normale, come ad esempio il gesto di origliare, unanimamente considerato
discutibile e condannabile, viene per certi aspetti riabilitato, come mezzo di
intimità profonda, di fratellanza nella nudità, laddove i rapporti con i vicini
di casa sono inesistenti ed il prossimo continua ad essere sempre un lontano. E
così la guerra, con i suoi orrori spaventosi, stupisce quando si comprende che
può trasformare ma non cancellare la vita che si conduce anche durante la pace:
“Con guerra si muore molto facile, senza cancro. Si spara, si piange e poi si
ama, come vagiaina mia e penis tuo. Poi si mangia, si dorme, si spara. Poi si
ama. Poi si prega. Poi si spara. Poi si ride. Poi si dorme. Poi si piange con
mitra vicino...Tutto normale in guerra e tutto normale in pace...” sostiene
Dru, la fidanzata croata di Simone, protagonista narratore. Evidente, dunque,
il gusto di rovesciare i luoghi comuni, dal momento che, proprio come afferma
Simone: “Di luoghi comuni siamo tutti bravi ad ubriacarci”. Per questo lo
psicologo protagonista di Cambio di programma, sembra quasi sfidare il
comandamento “non uccidere”, immedesimandosi nel ruolo di assassino per una
omonimia che basta di per sé per farlo sentire colpevole. Il racconto è
cadenzato dalla ripetizione di “capita” che vorrebbe normalizzare ciò che
invece non capita: attraverso questa ricercata insistenza “la realtà sabotata”
pare essere compagna dei nostri giorni, costantemente attraversati dai nostri
fantasmi.
Il Minotauro mangiato dai
giovani destinati al suo pasto è dunque il simbolo di questo rovesciamento che
ritroviamo in tutto il libro, necessario per poter essere in contatto profondo
con la verità di noi e non con quello che ci hanno raccontato, sganciato dalla
nostra esperienza emozionale, perché può farsi davvero racconto solo quello che
parte da dentro, solo il nostro racconto. Daniele rende possibile, grazie ai
semi di vero, che questi racconti diventino anche nostri racconti.
Per concludere, una delle
caratteristiche della narrativa di Daniele è quella grande capacità di trarre
lezioni dall'esperienza della vita oltre i luoghi comuni ed i personali mostri,
esperienza che per un amore profondissimo per le parole si tramuta
naturalissimamente in racconti: le lezioni emergono spontanee senza dita che
spuntano precettorie dalla cattedra e talora si concretizzano in sentenze
aforismatiche che in parte possono ricordare lo stile senecano nella capacità
di sintesi perfetta in cui non si può pensare una parola in più né una parola
in meno. Questa concettosità non appesantisce la pagina, perché la storia continua
a fluire senza intoppi, la rende soltanto preziosa, facendo capire che ogni
esperienza, anche la più drammatica e straniante, può diventare un serbatoio di
carburante che ci consente di procedere in una doppia direzione: quella della
verticalità e quella dell'orizzontalità, stabilendo quasi una proporzionalità
diretta in base alla quale più si scava nel profondo, più la vista personale si
allarga. Se si volesse trovare una metafora si potrebbe paragonare la raccolta
dei racconti ad una collana: vari fili dorati che sono le storie, sono
intervallati da perle lucenti, le massime, che brillano isolate e nello stesso
tempo perfettamente inserite nell'oggetto. Il consiglio è di acquistare questa
collana: la forza invisibile della sua bellezza sarà capace di impreziosire la
vita del lettore.
Daniele D'Arrigo. Il diario del minotauro. peQuod